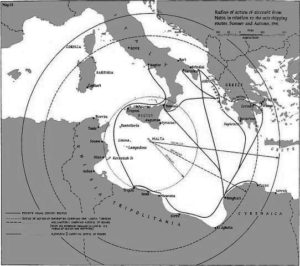Memorie – Volume primo
Certo di fare cosa gradita, LoSpeakersCorner.eu pubblica a puntate le memorie di guerra del preside Sante Grillo, che durante il secondo conflitto mondiale, nel 1943, era Sottotenente del 454° Nucleo Antiparacadutisti di stanza a Scicli, Ragusa.
Dedico questa mia piccola fatica ai miei cari lettori. Pochissimi, per la verità, ma non per questo meno cari e a … coloro che sono oggetto del mio affetto anche se non non tutti, oggi, possono percepirne il calore in questa nostra dimensione terrena.
Sante Grillo
Si va verso il Sud della Sicilia.
Un caporale dell’ufficio mi informò che l’aiutante maggiore desiderava parlarmi: la cosa mi sembrò strana dal momento che, di solito, mi chiamava personalmente usando il telefono interno. Infatti da qualche mese ero stato assegnato all’ufficio matricola ufficiali in sostituzione di un impiegato che nel frattempo si era ammalato. Incarico che mi era piaciuto moltissimo , tanto che quasi subito mi impadronii della situazione ed ero riuscito a rendermi quasi indispensabile. In ogni modo lasciai tutte le carte sulla mia scrivania e salii al piano superiore per sentire che cosa volesse.
Quando entrai vidi che ero stato preceduto da un certo numero di ufficiali che confabulavano fra di loro. Erano in tutto sei: due tenenti e quattro sottotenenti; io ero il quinto dei sottotenenti. C’era un po’ di sorpresa nel viso di tutti: evidentemente nessuno, come il sottoscritto, sapeva di cosa si trattasse. Per me era una novità in assoluto perché ero spesso chiamato a conferire con il mio superiore diretto, ma non con il aiutante maggiore. Non ci fu altro tempo perché proprio lui in persona entrò e noi lo accogliemmo sugli attenti. Ci salutò, sedette alla sua scrivania e venne subito al sodo.
«Vi ho convocato perché ho un incarico speciale per voi. Da questo momento ognuno di voi comanderà un nucleo antiparacadutisti di formazione e raggiungerà una propria sede come da piano prestabilito. Ogni nucleo avrà un suo numero di riconoscimento ed una sua sede. Vi sarà consegnato subito un foglio di viaggio e ciascuno di voi raggiungerà la sede stabilita per provvedere agli accantonamenti per il reparto. Vi auguro buona fortuna.»
Non ci fu data alcuna possibilità, non di replica, ma almeno di richiesta di ulteriori chiarimenti. Forse non c’erano alternative e i chiarimenti li avremmo ricevuti con successivi ordini, che avrebbero stabilito il perché ed il come.
Ci guardammo per un attimo con un moto di apprensione e uscimmo insieme dall’ufficio
Subito dopo, pur non sapendo ancora a che cosa si andasse incontro, cosa fosse un nucleo antiparacadutisti, quale fosse il suo compito, al di là delle parole che già lo definivano, venne naturale un grosso sospiro di sollievo: era certo che non stavamo andando in Grecia, che non stavamo per partire per la Russia, che non si andava neppure in Jugoslavia ed ancor meno nell’Africa Settentrionale; restavamo in Sicilia.
Le situazioni erano molteplici e non tutte erano desiderabili.
In Russia la situazione non era delle più brillanti: una quindicina di giorni prima era stato costituito un reggimento di formazione con la partenza di quasi tutti i quadri disponibili ed io non ero stato compreso perché al momento ero impegnato nell’ufficio matricola. Il reggimento aveva assunto il numero 333 e fu subito destinato nelle vicinanze di Catania dove avrebbe dovuto addestrarsi per affrontare le steppe russe.
Un’alternativa sarebbe potuta essere la destinazione in Jugoslavia in regime di occupazione da parte delle truppe italiane e tedesche. Avrebbe dovuto essere una zona pacifica ma le notizie che giungevano da quel fronte non erano “ rose e fiori”. Le truppe italiane erano spesso soggette ad agguati da parte dei cosiddetti partigiani e quelli che non morivano subito erano sottoposti a torture indicibili. Torture che facevano desiderare la morte.
In Africa settentrionale le cose sembravano che andassero meglio: in quel momento le truppe dell’Asse andavano avanti ma dopo ritirate così dette strategiche che non facevano bene sperare in azioni future, visto che il fronte si era spostato spesso ora avanti ora indietro.
Era evidente che qualunque altra alternativa non era appetibile e quindi il nuovo incarico con la nuova destinazione era, diciamo, accettabile. Eravamo destinati tutti nella provincia di Ragusa ed io avrei dovuto raggiungere Scicli. Non l’avevo mai sentita nominare ma non dubitavo che esistesse giù nel profondo della Sicilia.
Il mio primo movimento fu quello di andare a consultare una carta geografica che mi facesse avere una migliore conoscenza circa l’ubicazione del paese E così ebbi la certezza che bisognava scendere giù, giù in fondo alla Sicilia per riconoscerla in un puntino che spuntava timidamente dalle propaggini dei monti Iblei.
Ci informarono che al ritorno dalla missione esplorativa ci sarebbe stato assegnato il reparto oltre ai materiali indispensabili. Il mio reparto sarebbe stato il 454° Nucleo Antiparacadutisti.
Il viaggio non fu dei più semplici ma poiché eravamo in sette, trovammo il tempo per scherzare e ridere anche se nel profondo dell’animo il nostro pensiero andava inevitabilmente alle nostre famiglie e ad un futuro che non potevamo conoscere per la novità del compito e del territorio nel quale avremmo dovuto operare.
I nuclei in questione erano reparti operativi in modo assolutamente autonomo ed in dipendenza di fatti imprevedibili fra i quali, naturalmente, il lancio di paracadutisti nemici.
Dopo Siracusa cambiammo treno: le vetture erano ancora più antiquate, la velocità, ridottissima, i binari sconnessi e cominciò la solfa delle fermate, delle fermatine, dei ritardi, comunque si andava avanti e ad Ispica scese il primo di noi, poi scesi io.
Durante il viaggio avevamo avuto il tempo di sceverare tutte le nostre supposizioni su quanto avremmo dovuto fare con i nostri reparti. Ognuno di noi ci mise la sua nel crogiuolo delle supposizioni e ne venne fuori una miscellanea di considerazioni che spesso non collimavano fra di loro.
Dopo Scicli sarebbero scesi gli altri a partire dalla fermata successiva che sarebbe stata Ragusa. A guardare bene sulla carta geografica i paesi ai quali eravamo destinati formavano un grande ventaglio con il centro di radiazione nel capoluogo di provincia.
Quando saltai giù dal treno ero un po’ frastornato: ero solo e mi rimaneva la curiosità a tenermi compagnia.
Mi venne incontro un sottufficiale che conosceva il mio nome e che mi accompagnò al Comando del Presidio. Temevo peggio e ritenni il fatto bene augurante ma, guardandomi intorno, il paesaggio era brullo ed il paese mi parve situato al fondo di un grande tegame: circondato interamente da colline tufacee con profonde fenditure di roccia e sentivo un caldo pazzesco. Feci spallucce, ero ormai lì e non avevo altra scelta, per il resto si sarebbe visto.
Questa volta , però, ero solo ad affrontare il viaggio uesta volta,però, ero solo ad affrontare il viaggio di ritorno al Comando di Deposito del 3° Reggimento Fanteria e forse per questo risultò lungo e stressante anche perché non avevo niente che mi servisse di distrazione: la mia mente andava inevitabilmente alla mia nuova situazione che non era preoccupante e lasciava margini molto vasti alla iniziativa, iniziativa alla quale per la verità non ero stato educato. Comunque era un fatto nuovo che non mi dispiaceva.
Mi sarebbe mancata la famiglia, questo sì, e per me sarebbe stato molto pesante visto e considerato che io vi ero rimasto per venti anni a trascorrervi la mia giovinezza e vi avevo compiuti i miei studi fino alla laurea.
Certo, avrei dovuto lasciare a tempo indeterminato la mia ragazza anche se questo non risultava il mio problema essenziale. C’era tuttavia in me come una grossa percentuale di rassegnazione unita certamente al grande senso di adeguamento ai fatti che stavano per maturarsi, almeno per la mia persona.
Il senso del dovere poi, un poco innato , un poco acquisito con l’educazione dentro e fuori della famiglia, completava il quadro.
Sapevo che questo nuovo compito mi avrebbe allontanato in modo sensibile da teatri di guerra ben più pericolosi ma non ero allegro: malgrado le notizie dei progressi che i nostri facevano su tutti o quasi tutti i fronti a me pareva che il fatto di dover ricorrere a reparti specializzati sul nostro stesso territorio facesse intendere che le cose non potevano essere considerate del tutto scevre da previsioni sfavorevoli. Lo sapevo, era soltanto una sensazione e non frutto di un ragionamento basato su dati oggettivi.
C’era poi la convinzione che l’improvvisazione e quindi la impreparazione di reparti cosiddetti speciali non andasse a tutto vantaggio dei reparti stessi. Più riflettevo sulla loro costituzione e sul loro armamento e più mi rendevo conto che qualcosa non andava alla perfezione. “Antiparacadutista”, era una definizione che portava il reparto ad un concetto di super-dotazione, di un addestramento specifico che comprendesse insieme a tante altre cose anche la perfetta conoscenza del nemico, delle sue armi, dei suoi metodi, che avesse, come dotazione, un armamento adeguato e che numericamente potesse affrontare anche situazioni di svantaggio, nel caso ce ne fosse il bisogno. Invece … eccoti battezzato antiparacadutista, come con un colpo di bacchetta magica con un gruppo di uomini che ancora non conoscevo ma che certamente avrebbero dovuto essere prelevati da uomini già provati da ferite o da altri malesseri che non li aveva fatti destinare a fronti ben più impegnativi.
A Siracusa dovetti pernottare in una caserma adibita alle truppe di passaggio in una stanzetta destinata agli ufficiali, le finestre erano oscurate, le luci interne del tutto insufficienti, ed io dovetti arrangiarmi come potevo.
Dopo pochi minuti avvertii il suono delle sirene: era l’allarme aereo ma io non ci feci molto caso perché ero abituato agli allarmi subiti a Messina. Mi aspettavo di sentire la contraerea entrare in azione ma ci fu il silenzio assoluto ad eccezione di un affrettato movimento di persone che andavano a raggiungere i ricoveri.
Io mi mossi con lentezza, non per coraggio ma per l’abitudine ad altro frastuono: a Messina la reazione aveva ben altro spessore: le navi da guerra che stazionavano nel porto ricorrevano a tutti i mezzi a disposizione per creare una gabbia in cui gli aerei avrebbero dovuto pensarci due volte, e non due volte soltanto, per entrarvi senza pagare pedaggi.
Il porto di Messina serviva da sede per ben tre incrociatori pesanti, il Trento, il Trieste e lo Zara. Nella loro stazza sembravano più a corazzate che incrociatori ma nelle loro linee apparivano agilissime e straordinariamente belle, oltre che maestose.
Non stazionavano mai sulla stessa linea ed erano protetti da reti di cui si scorgevano i galleggianti. Erano uno spettacolo al solo vederli.
Il fatto è che qualche volta andavi al porto e gli incrociatori erano spariti, non li vedevi più. Certamente erano scivolati via silenziosamente per missioni di guerra. Tanto che qualche volta queste assenze coincidevano con nottate di furore e di fuoco che producevano come il rimbombo di tuoni da tempesta in lontananza.
Quando tornavano li vedevi lì, altrettanto silenziosi di quando erano partiti ed il cuore ti si apriva alla gioia e ringraziavi Iddio per averti concesso di vederli ancora sani e forti come prima.
Più di una volta accadde che la loro riapparizione coincidesse con un via vai straordinario di ambulanze che sfurettavano per le vie della città fino agli ospedali di periferia.
Erano i giorni neri di Punta Stilo o, per meglio dire, le notti di Punta Stilo dove i bagliori di luminarie immense in lontananza si confondevano con il rumore dannato di un lungo cannoneggiamento.
Una mattina sul molo principale del porto era attraccata dalla parte della poppa la corazzata Giulio Cesare.
Sembrava per quasi tutta una paratia annerita dal fumo, certamente a causa di un incendio a bordo ed era abbondantemente inclinata da un lato. Molte barelle venivano trasportate dall’interno della corazzata fino al molo dove venivano immesse sulle ambulanze. Intorno c’era molta folla, attonita, in religioso silenzio ad osservare quel trasferimento di corpi umani in tragica sequenza senza che ne venisse fuori un lamento, un grido di dolore, una lettura di sofferenza, testimonianza di un tragico sacrificio. Non c’era posto per esternazioni di alcun genere, ma il pallore sui volti, il silenzio stesso erano più rappresentativi di qualsiasi discorso.
Quando invece si era sotto attacco aereo si provava la sensazione di quando si assisteva ad uno spettacolo pirotecnico straordinario, anche in considerazione del fatto che tutte le colline che circondavano la città erano la base di batterie contraeree che vomitavano fuoco da tutte le bocche talvolta in un crescendo rossiniano ma di ben altra portata e natura. D’altra parte c’era da difendere una base navale importantissima.
In quelle occasioni, non appena si sentiva il segnale di allarme. Noi, già militari in divisa ed io, da fresco sottotenente, dovevamo correre in caserma per essere disponibili ad ogni evenienza. Dovendo vestirmi in fretta , accadendo spessissimo durante le ore notturne tenevo tutto pronto in modo che potessi impiegare il minor tempo possibile e poi via di corsa anche sotto il bombardamento , pericoloso, anche solo per gli spezzoni che cadevano dovunque e con una frequenza sensibile. Gli spezzoni erano quelli riferiti alla contraerea.
Accadde solo qualche volta che gli spezzoni fossero quelli lanciati dagli aerei e per lo più incendiari lungo la strada ferrata e nei pressi della stazione marittima. Erano questi i pensieri sempre presenti nel mio cervello dove i fatti e le immagini erano come scolpiti indelebilmente.
In qualche modo la notte passò: ero assonnato ma tutto sommato era andata bene ed a Siracusa le batterie non avevano sparato.
Quando mi rimisi sul treno ripresi i miei pensieri ma spesso ero distratto da un paesaggio straordinario soprattutto nel tratto che andava da Catania a Messina: il mare era lì a portata di mano, il suo colore era di un azzurro intensissimo interrotto qua e là da molteplici scogli che mi riportarono ai mitici tempi dei Ciclopi che la mitologia voleva autori di quelle isolette quando, quasi per gioco, intendevano colpire con il lancio di enormi blocchi di roccia, staccati dalla montagna, i malcapitati naviganti.
A Messina si fece tutto in fretta: i reparti vennero approntati e forniti di tutto il materiale necessario per una vita indipendente, ci assegnarono le armi e poi via su una tradotta militare, approntata solo per noi.
In quella occasione rividi gli ufficiali, che la prima volta erano partiti insieme a me e così potemmo scambiarci notizie ed opinioni. Da quello che mi risultò, pensai di non essere andato tanto male in fatto di destinazione perchè altri miei colleghi non avevano rose e fiori da raccontare. Il paese a me destinato era un centro agricolo abbastanza importante, con un numero maggiore di abitanti rispetto a tanti altri del circondario.
Se poi avessi dovuto rapportare le mie considerazioni con quello che avevo visto al Comando di Reggimento certamente il paese avrebbe potuto essere considerato di una notevole ricchezza. Il Comando, infatti, aveva sede in un palazzo bellissimo dalle sale immense e super decorate con stucchi ed affreschi stupendi: le baronie ancora esistevano.
In un doppio scompartimento di terza classe ci disponemmo noi ufficiali dopo aver controllato gli uomini, i materiali, le armi in dotazione e tutto il resto. Ognuno di noi prese in carico trenta militari di cui due sottufficiali, due caporali e ventisei uomini di truppa scelti alla rinfusa dai residui di materiale umano esistente nel Deposito.
Ancora non ero in grado di valutare la qualità dei miei uomini ma da un primo esame mi apparvero alquanto depressi soprattutto in materia di entusiasmo: qualcuno proveniva da altri fronti di guerra e nel fisico non sembravano in buona forma. Era tutto ciò che offriva la piazza, non bisognava dimenticarlo, in effetti era ciò che rimaneva a disposizione degli effettivi del terzo reggimento di fanteria inviato sul fronte greco, dei suoi innumerevoli complementi inviati frettolosamente in sostituzione di quegli uomini che risultavano feriti, soprattutto congelati, dispersi per la massima parte nei momenti meno fortunati della campagna. ed i morti
Tra questi ci fu un mio cugino, granatiere, che non fece in tempo a nascondere la sua statura nelle trincee di fortuna scavate in tutta fretta nel fango di una stagione molto piovosa.Da borghese aveva esercitato lo sport da lui preferito:il lancio del martello, specialità non molto seguita ma che per lui aveva una particolare attrazione. Di tanto in tanto mi accadeva di vederlo esercitarsi nel lancio e di ammirarlo nello stesso tempo. Ora era uno dei tanti che aveva consegnato la vita alla Patria.
In attesa di nomina a sottotenente avevo chiesto di essere destinato al 3° Reggimento di Fanteria perché avevo saputo della destinazione in Albania di mio fratello, brigadiere dei Carabinieri. Pensavo che potesse verificarsi il miracolo di un incontro nel caso in cui io stesso fossi stato destinato su quel teatro di guerra. Invece per un destino assolutamente diverso il treno mi stava trasportando verso l’ultimo lembo della Sicilia.
In quei casi, penso, fosse meglio non provare sentimenti. Forse i miei desideri sarebbero stati più soddisfatti se mi fosse stata data la possibilità, anche se difficile, di incontrare mio fratello. Lo avevo sperato tanto perché per lui non avevo soltanto affetto ma provavo una devozione straordinaria, ancor più che per mio padre. Invece…
Per un reparto che intendeva opporsi validamente a truppe super addestrate come i paracadutisti non c’era proprio molto da stare allegri in fatto di armamento. Forse andavamo un pochino meglio per i mezzi, essendo forniti di un camion, di una motocicletta e di due biciclette, queste ultime nuove fiammanti.
Le considerazioni che facemmo nei nostri scambi di idee non furono certamente euforiche, tuttavia il fatto che qualcuno di noi pensasse che potevamo andar peggio ci consolò in parte e non continuammo il discorso, quando uno degli ufficiali affermò che il tutto rispondeva alla necessità di un impiego rapido che non poteva trovare riscontro se non nella leggerezza con cui dovevamo muoverci in caso di una immediata chiamata all’azione. Non capii perfettamente se in quella dichiarazione ci fosse un pizzico di ironia; non ebbi il coraggio di chiederglielo.
Due fucili mitragliatori, trenta fucili modello novantuno, due pistole d’ordinanza in dotazione ai due sottufficiali e due pistole da segnalazione forse non erano l’optimum per un volume di fuoco che facesse paura a paracadutisti armati fino ai denti, perfettamente addestrati e non soltanto sui lanci dagli aerei. Forse valeva di più la grinta di chi impugnava quelle armi. Mi accorsi a quel punto che ero io a fare un poco di ironia.
Scicli (Ragusa)
Quando arrivammo a Scicli avevamo le ossa rotte, tutti indistintamente, ed il mio pensiero andò immediatamente ai poveretti che avrebbero dovuto fare il resto del viaggio in condizioni ancora peggiori. Le linee non erano delle migliori e le vetture erano delle peggiori, o, forse, era meglio dire che al peggio non c’era fine.
Per me e per il mio reparto cominciò una nuova avventura e speravamo bene; sul viso di molti si leggeva intanto il piacere di permettere alle ossa di rilasciarsi.
Alla stazione non trovammo nessuno ad attenderci: non era un buon auspicio ma non c’era di che allarmarsi. Zaino a terra in forma di cerchio, i soldati si misero seduti in attesa che il sottoscritto andasse a sincerarsi della situazione.
Al Comando di Presidio il capitano addetto non c’era, forse perché erano ancora le prime ore del pomeriggio.
Il piantone trovò gli ordini scritti su un foglio di carta fermato da un posacenere di cristallo ma non mi venne consegnato perché doveva essere visionato dall’ufficiale di servizio: era giustissimo. Solo che l’ufficiale di servizio stava da qualche parte e l’ edificio che ospitava il Comando era molto grande.
La sala in cui attendevo era grandissima e molto bella, piena di stucchi e pitture, anche i mobili erano antichi ma io non seppi valutarli perché non m’intendevo di stili. Non osai sedermi su un’invitante poltrona e restai in attesa in piedi con il berretto fra le mani: ero un po’ nervoso ma era comprensibile visto che ero in uno stato d’ansia giustificata.
I miei soldati stavano aspettando e non erano del tutto riposati, avevano piuttosto bisogno di ristorarsi e, se permettete, anche di dormire.
L’ufficiale c’era, venne però senza eccessiva fretta, mi salutò e mi dette il benvenuto.
«È tutto a posto … », disse, e mandò a cercare un sottufficiale per farmi da guida fino all’accantonamento, per la fureria e per il mio alloggio. «Bene!»: una stretta di mano e via con la mia guida.
Cominciai a guardarmi intorno ma non feci alcuna considerazione , osservavo e recepivo con l’intento, forse, di trarre le mie considerazioni in un secondo tempo, quando avessi avuto maggior tempo e maggior serenità di giudizio: in quel momento ero in ansia e terribilmente stanco.
Iniziavano così le prime delusioni e le voglio elencare tutte, o quasi, perchè soltanto in questo modo si ha la possibilità di valutarle nel suo insieme.
L’accantonamento era un ex deposito di derrate in terra battuta senza alcun servizio igienico con giacigli ricavabili da diverse balle di paglia che aspettavano ancora di essere sistemate. I soldati erano troppo stanchi per accorgersene o forse se ne accorsero ma non avevano voglia di parlarne.
Il comando del reparto che doveva ospitare l’ufficio amministrativo ed operativo era sulla strada che andava verso il centro a ben quattrocento metri di distanza.
 Il mio alloggio, in comunione con altri ufficiali di artiglieria era posto in un vicolo alle spalle del Comando di Reggimento a più di dieci minuti di distanza dal cosiddetto comando e a più di venti minuti dall’accantonamento. C’era da salutare definitivamente il pronto impiego: ancora non mi resi conto esattamente dell’inghippo che ne sarebbe venuto fuori e pertanto rinviai il riesame della situazione per almeno dodici ore.
Il mio alloggio, in comunione con altri ufficiali di artiglieria era posto in un vicolo alle spalle del Comando di Reggimento a più di dieci minuti di distanza dal cosiddetto comando e a più di venti minuti dall’accantonamento. C’era da salutare definitivamente il pronto impiego: ancora non mi resi conto esattamente dell’inghippo che ne sarebbe venuto fuori e pertanto rinviai il riesame della situazione per almeno dodici ore.
La sera stava per sopraggiungere e occorreva ancora sistemare moltissime cose: per esempio, dove e come avremmo mangiato il giorno dopo, dove avremmo dovuto prelevare le razioni, dove avremmo dovuto rivolgerci per il rifornimento di benzina per le macchine in dotazione e tante piccole e grandi cose che avrebbero dovuto far funzionare in maniera ottimale un reparto a cui si chiedeva un impegno di tutto rilievo.
Vista la gentilezza con la quale ero stato accolto la prima volta a Scicli non dubitavo minimamente della piena disponibilità del Comando di presidio a risolvere i miei problemi. Forse non era stato compreso bene il compito che spettava al mio reparto e le sue essenziali caratteristiche di impiego celerissimo.
Il giorno dopo il capitano addetto al Presidio mi fece sapere che non c’erano altre disponibilità nel paese e quindi non esistevano alternative: prendere o lasciare. Chiesi di poter parlare con il comandante del Reggimento ma il Colonnello non c’era. Il capitano fu formalmente cordiale ma la sua voce si fece più dura e capii che non amava essere scavalcato. Certamente non poteva opporsi alla mia richiesta ma non mancò di farmi capire che era una richiesta “blasfema”, perché lì si era abituati solo ad ubbidire.
Avevo capito l’antifona ma ero determinato ad andare avanti per quello che consideravo l’interesse del reparto per cui, prima di allontanarmi,confermai la mia domanda. Non era certo un mio capriccio e l’esigenza di impiego immediato richiedeva che il comando, l’alloggio del comandante ed il reparto fossero una unità omogenea e perfettamente amalgamata.
Il giorno dopo, sistemate alcune cose essenziali per il reparto, tornai al Comando di Presidio e pregai il capitano di avere la cortesia di ascoltare le mie istanze visto che il colonnello comandante era ancora in viaggio di ispezione. Il capitano mi disse che nella vita privata esercitava l’avvocatura, mi fece sedere comodamente e si dispose ad ascoltarmi con una buona carica di pazienza.
Io non andai per il sottile e quindi gli spiegai le esigenze che mi imponevano di insistere nelle mie richieste. Alla fine riuscii ad ottenere il permesso di vedere personalmente sulla piazza quali altre possibilità ci fossero e quindi di riferirgli tutto quello che avrei trovato.
Ringraziai alquanto sollevato: non immaginavo che anche quello che stavo per fare era un modo per offendere la sua personalità e per mettermi a contatto con una realtà che non doveva essere modificata senza il suo benestare. Chiesi cortesemente di essere chiamato per presentarmi al colonnello non appena fosse stato possibile.
I soldati ed i miei sottufficiali non solo non si lamentarono ma sorrisero dinanzi alle mie preoccupazioni per l’organizzazione del reparto. Non avevano ancora molta confidenza con me e non volevano sbilanciarsi più di tanto, però compresi che, secondo la loro esperienza nei precedenti reparti non si badava a certe sottigliezze.
Per chi come loro era abituato al fango, alla pioggia, al freddo ed al caldo oltre che al pericolo, era come poter stare in una bella casa con tutte le comodità possibili.
Non capivo come avessero la voglia di sorridere dinanzi a quello che io, invece, consideravo un disastro. Non era possibile, mi dicevo, che fossimo trattati come bestie e non come esseri umani soprattutto perché ero convinto che esistessero altre soluzioni certamente migliori di quelle. Comunque fui costretto, mio malgrado, a rinviare la soluzione del problema.
Tra le tante cose che dovevamo risolvere insieme c’era l’adozione di un motto che ci rappresentasse in modo fuori dal comune, ed un napoletano, fra le tante battute ci suggerì “ca’ nisciuno è fesso”. Stavamo mangiando insieme ed insieme approvammo il nostro motto. Lo scrivemmo in grande su un cartoncino e lo affiggemmo dietro la mia scrivania in buona mostra per chiunque venisse nella saletta del comando. Capivo che il motto era anche una sfida, ma in fin dei conti era in linea con i nostri sentimenti, la nostra delusione ed il nostro dispetto.
Non potevamo fare altro e la vita militare non ci concedeva molto di più o forse quello era già un di “più”.
Nei giorni successivi, a mezzo ferrovia, giunsero il camion, la motocicletta e le due biciclette. Non avevamo il gasolio e per spostare il camion facemmo leva sui nostri muscoli per trascinarlo fin vicino alla sede del comando dove trovò la sua posizione in un vicoletto laterale.
Come si suole dire mi misi ”in caccia”: andai girando per il paese, parlai con qualcuno che mi sembrava rappresentativo nella cittadina e dopo poche ore riuscii a parlare con un signore che sarebbe stato ben felice di cedermi i suoi locali che risultavano ben raccolti e dove avrei potuto trovare alloggio io stesso.
I problemi logistici mi sembrarono risolti con un solo colpo. Vi era tutto ciò di cui avevamo bisogno: un gran salone per ospitare più di venti soldati, un ripostiglio per depositarvi il materiale di cui eravamo dotati, le armi, una stanzetta per me, una grossa cucina. L’unico inconveniente sembrava una piccola scalinata all’entrata del locale. Dovevo solo parlarne con il capitano addetto al presidio: al Comando non c’era e quella volta non era il primo pomeriggio: evidentemente aveva molto da fare.
Pregai l’ufficiale di servizio perché mi mandassero a chiamare e me ne tornai al mio piccolo comando che di proposito scrivo con la “c” minuscola. e misi a posto tante piccole cose che però risultavano essenziali per un migliore funzionamento del reparto in caso di emergenza.
Il problema dei locali sembrava risolto ma dovevo mettere a punto qualche particolare sull’avvistamento e per questo mi occorreva fare una ricognizione molto più approfondita. Intanto una cosa era certa: un posto di avvistamento nel centro dell’abitato era assolutamente impossibile data la posizione defilata del paese rispetto alla linea dell’orizzonte.
Al reparto mi ritrovai con i soldati con i quali divisi le mie preoccupazioni e con mia grande sorpresa mi accorsi che nessuno di loro era indifferente alla problematica e trovai inoltre una competenza che non mi sarei mai aspettata. Soprattutto i reduci da altri fronti ed in particolar modo dal fronte greco-albanese, erano pronti a discutere con cognizione di causa ogni problema.
Da questa discussione vennero messe in evidenza carenze che pensavo di aver avvertito soltanto io. Notai con immenso piacere che al di là di tutto mi guardavano con molta simpatia anche se erano ancora pochi i giorni trascorsi insieme. Forse c’era anche atmosfera di amicizia derivata dalla incombenza delle feste natalizie: si sa bene che in queste occasioni si tende a fraternizzare per quel maggior calore che si richiama all’ambiente familiare di cui tutti, indistintamente tutti, sentivamo la profonda nostalgia.
Per parte mia era la prima volta che mi trovavo lontano da casa da cui non era stato facile staccarmi e che ora nell’imminenza del Natale sembrava ancora più lontana. Non è difficile immaginare quali pensieri si rincorressero nella mente e quali immagini mi si presentassero come su un palcoscenico non molto vicino ma di cui riconoscevo i contorni familiari purtroppo velati da un sipario non troppo generoso.
Nostalgia? Sì, nostalgia forte e penetrante che a volte sembrava togliermi il respiro soprattutto quando lo accostavo ad una realtà deludente come quella nella quale ero sprofondato senza l’apporto della mia volontà.
Tornando alla realtà facemmo anche il punto sulle vicende belliche e commentammo le notizie che ci giungevano dai bollettini. Non tutti erano d’accordo sulla loro veridicità specialmente i reduci da altri fronti che non erano disposti ad accettare supinamente l’ottimismo delle informazioni. Evidentemente facevano il confronto con le loro vicende vissute e le comunicazioni ufficiali sulle stesse vicende. Spesso, mi dicevano, le cattive notizie venivano del tutto taciute anche se importanti, mentre venivano evidenziate quelle buone ma meno importanti.
Queste considerazioni mi lasciavano l’amaro in bocca perché difficilmente riuscivo a pensare che la nazione venisse male informata di proposito con l’evidente fine di non deprimere la popolazione o per non informare direttamente il nemico. Però per l’uno o per l’altro fine c’era una verità negativa, che dichiarata o non dichiarata, restava sempre negativa.
Alla fine c’era da pensare che la verità la sapevano soltanto in pochi oltre, naturalmente, coloro che l’avevano vissuta sulla loro pelle. Una realtà, questa, che non era facile da digerire per cui non era possibile dare credito alle dichiarazioni così dette ufficiali. Io, personalmente, ero straordinariamente deluso e difficilmente mi adattavo all’idea.
Il territorio
A cominciare dal giorno dopo, carta topografica alla mano, cominciammo le prime ricognizioni sul territorio; infatti uno dei più importanti fattori dell’impiego era proprio la perfetta conoscenza del terreno che ci avrebbe messo nellecondizioni migliori per una possibilità positiva in più in caso di eventuale scontro.
Occorreva, inoltre, la possibilità di orientarsi secondo i punti cardinali da un non ancora trovata postazione di osservazione. Pensai ad un piccolo sistema, poco costoso, che avrebbe potuto consentire di traguardare ed indicare automaticamente in quale punto si verificasse lo sbarco eventuale di paracadutisti.
Il sistema che avevo in mente era molto semplice: due cerchi concentrici di cui uno fisso e graduato a 360°, l’altro in grado di ruotare, sul quale si sarebbe dovuto costruire un piccolo mirino che consentisse di traguardare dalla parte opposta. Il disco sottostante, fermo su una base, permetteva di girarvi intorno e quindi, guardando il bersaglio, di poter stabilire in quale direzione si verificasse l’evento. Veniva comunque difficile calcolare la distanza che soltanto l’esperienza e l’esercizio potevano indicare con qualche approssimazione.
Il giorno dopo avrei commissionato l’apparecchio ad un falegname ed intanto con l’osservazione sul terreno avrei cercato di individuare il punto da cui poter spaziare su tutto o quasi tutto l’orizzonte.
Ripasso, come posso, i nomi dei miei ragazzi. Ragazzi, è un modo di dire. Qualcuno era più grande di me.
Dei due sergenti, uno era addetto alla fureria e portava avanti tutta l’amministrazione. anche se mi sembrava un po’ “sbruffoncello”. Era alto, tendente alla pinguedine, parlava troppo per il mio carattere. Tuttavia pareva conoscere il suo mestiere anche se aveva il difetto di scherzare su tutto, anche nei momenti in cui sarebbe stata necessaria un pochino di serietà in più. Era un maestro elementare ma in quanto a cultura lasciava a desiderare, tanto è vero che cambiava discorso tutte le volte che si parlava in modo, diciamo, impegnativo. Ma a me questo interessava fino ad un cero punto: non eravamo in una scuola e non doveva insegnare l’alfabeto a nessuno, anche se, purtroppo, alcuni dei miei soldati erano addirittura analfabeti.
L’altro era sergente e addetto alla truppa: di statura non troppo alta, ma risultava ben proporzionato, agile e si faceva sentire anche se il suo tono sembrava quasi confidenziale.
Il caporale proveniva dall’Abruzzo, aveva una parlata piuttosto stretta ed il suo italiano era abbastanza corretto con una pronuncia dalle a e dalle o molto chiuse. Veniva direttamente dall’ospedale dal quale era stato appena dimesso per congelamento al piede sinistro. Noia, che lo costringeva a zoppicare lievemente. Bisognava saperlo per accorgersi di questo suo difetto. Promosso caporale sul campo, era stato insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Faccio un pensiero cattivo: se fosse stato un ufficiale avrebbe ricevuto per lo meno la Medaglia d’Argento.
Raccontava la sua vicenda con molta semplicità e come se quello che aveva compiuto fosse del tutto normale e per persone normali. Mi piaceva moltissimo perché, fra l’altro, parlava poco ed eseguiva con intelligenza tutto quello che gli si diceva di fare.
Ecco in sintesi quello che era accaduto: Il suo reparto è bloccato da un nido di mitragliatrice che spazza tutto quello che entra nel suo raggio d’azione. Alcuni dei suoi compagni cadono ancor prima che si rendano conto di ciò che sta succedendo. In effetti sono sorpresi mentre stanno per raggiungere il fondo di una piccola valle e debbono subito correre ai ripari dietro piccoli ostacoli che offre loro la natura, come qualche tronco spezzato o qualche buca provocata dall’esplosione di bombe da mortaio.
In verità è troppo poco per offrire riparo a molti di loro che si trovano in un batter d’occhio ammassati in pochissimi metri quadrati. Qualcuno cerca di rendersi conto di che cosa sta succedendo ma quando cerca realmente di farlo deve tirarsi giù più che in fretta per non essere colpito mortalmente. Non c’è proprio che fare e non si può neppure tornare indietro. Evidentemente sono stati attesi fino a quando non si sono scoperti del tutto senza alcuna possibilità di andare avanti o tornare indietro.
S. si sente morire ed il petto gli fa tremendamente male perché un suo compagno che sta su di lui gli preme con un ginocchio piegato innaturalmente sulle costole. Malgrado cerchi con ogni sforzo di liberarsi del ginocchio si accorge che per togliersi da quella posizione scomodissima deve tirarsi fuori dalla buca, cosa che in quel momento non è possibile se non per andare incontro alla morte. Allora cerca di girarsi su se stesso per evitare l’insostenibile peso sul petto. Vi riesce dopo sforzi inauditi proprio per la quasi impossibilità di movimento e soltanto allora riesce a poter capire che cosa sta succedendo. Sente qualche lamento ma non può farci niente, non capisce neppure da quale direzione provenga. Per lui è un tormento restare fermo senza poter agire ed alla fine decide che è preferibile morire piuttosto che restare lì in balia della sorte.
Comincia così a fare dei movimenti millimetrici fino a quando non riesce a vedere intorno a sè per qualche metro. È appena coperto da un piccolissimo rilievo e comincia a pensare che da quel lato forse è possibile muoversi, sempre che il nido di mitragliatrice non sia più in alto del rilievo stesso. Ci prova, ma una sventagliata di colpi gli impedisce di andare oltre. In compenso ha capito da dove provengono i colpi e raffigura più o meno la posizione della stessa mitragliatrice. Intanto comincia a farsi buio per buona fortuna, ma i colpi arrivano ugualmente perchè quasi certamente la macchina bellica è stata posizionata a dovere.
Non se la sente di restare in quella posizione e preferisce muoversi anche a costo di morirne. Comincia a strisciare lentamente tenendosi, per quello che è possibile, dietro al piccolo rilievo dietro al quale crede di trovarsi. Ha appena percorso qualche metro quando il cielo si illumina di colpo in seguito all’accensione di diversi bengala: la zona è illuminata a giorno, si sente come se fosse completamente nudo e si blocca un poco per paura un poco perché gli hanno insegnato che solo rimanendo assolutamente fermi si può non essere visti.
Comunque il cuore batte furiosamente e comincia a pentirsi della sua audacia. Per la verità non è neppure sicuro che si tratti di coraggio: infatti si è mosso soltanto perché ha paura.
Finalmente i bengala si spengono ed allora affretta i suoi movimenti nella speranza di raggiungere qualche altro riparo prima che i bengala tornino a riaccendersi. Subito dopo il cielo torna a rischiararsi in modo abbagliante, ma ormai ha attraversato lo spazio che si era dimostrato il più pericoloso: ha la sensazione di aver fatto qualche progresso nel tentativo di raggiungere la piccola valle ed infatti sente gorgogliare leggermente un rivolo d’acqua.
Anche questa volta attende che si rifaccia il buio per muoversi ma deve riabituarsi all’oscurità e deve orientarsi meglio per capire, da questa nuova posizione, dove si trova la mitragliatrice. Non passa molto tempo perchè una sventagliata di traccianti gli indichino con precisione da dove partono i colpi.
Ora si muove con circospezione ma con maggiore rapidità: ha capito che occorre girare al largo nella speranza che non vada a finire nella direzione di tiro di qualche altra postazione nemica.
La fortuna non lo abbandona e ad un certo momento si ferma: ha assoluto bisogno di sapere dove si trova ma ha la sensazione di aver superato in avvolgimento il nido di mitragliatrice ma non può esserne sicuro. Ad un certo punto vede un piccolo bagliore nel buio più nero e intuisce la direzione ma non ha idea della distanza che lo divide dal nemico. Tenta di rilasciarsi ma né il cuore né il tremolio intenso delle mani gli indicano che la tensione si è allentata.
Il tenente comandante del plotone è preoccupato, ha capito le intenzioni di S., lo ha visto sparire nell’oscurità. Conosce la sua intemperanza ma non può valutare in pieno tutto il suo programma che, come al solito, sfugge ad ogni possibile interpretazione.
Quando incomincia a non percepire più nessun segno dei suoi movimenti né con l’udito né con la vista nei momenti interminabili in cui i bengala restano appesi nel cielo, pensa che ha fatto male a non intervenire per impedire ogni suo movimento. Con la fantasia tormentata dal timore, lo vede vittima di una sventagliata fatale di colpi tirati alla cieca in un buio sempre più fitto. Comunque, la preoccupazione di una situazione sempre più disperata degli altri suoi uomini lo distoglie: deve provvedere alle loro necessità e soprattutto alla loro sicurezza che in questo momento è davvero precaria.
Vorrebbe recuperare il consiglio del suo comandante di compagnia ma non ha più idea di dove si trovi in quel marasma di balletto con la morte. Sospira, e per un attimo pensa alla sua non felice posizione: gli avevano fatto capire che tutto sarebbe stato facile, che tutto sarebbe andato liscio come l’olio, che nel peggiore dei casi, il nemico avrebbe fatto dietro front e se la sarebbe data a gambe levate.
Ora, invece, si trova lì in una situazione che, a dir poco, è assolutamente imbarazzante con un nemico agguerritissimo di fronte, un comando superiore che non sa neppure dove sia, un reparto appiattito su un terreno infido ed un uomo che sfugge al suo controllo senza aver la possibilità di fermarlo o, per lo meno, di sapere che intenzione abbia, sempre che non sia da considerarsi già perduto: non ha la minima possibilità di accertarsi che fine abbia fatto.
L’unica cosa che può fare – e la fa senza indugi – è quella di dare una certa sicurezza agli uomini che ancora può controllare e così ordina a chi gli sta più vicino di scavare delle trincee provvisorie in modo da tenersi più bassi . E così il lavoro si fa frenetico nei momenti in cui non si spara ed i bengala non illuminano il terreno. Quando questo accade tutto si ferma e il silenzio diviene tombale, si cristallizza persino la paura e nel petto di ciascuno i battiti del cuore non si sentono più: sono le tempie che ora pulsano freneticamente e le mani non riescono a stare più ferme.
Il giovane tenente pensa, per un fenomeno di sdoppiamento, che la realtà in cui si trova completamente immerso sia un’altra, che lui stesso viva in una realtà diversa, distante tanto da non riguardare la sua persona e che, pertanto , non ha alcun motivo per temere e che il suo muscolo cardiaco con le sue pulsazioni affrettate sia al di fuori del suo corpo.
Per un qualcosa che non sa spiegarsi e che non ha neppure il tempo di chiarire a se stesso esce dalla precarietà della situazione e si rinfranca. Le raffiche di mitraglia che ora hanno ricominciato a farsi sentire sembrano non riguardarlo più, anzi le loro luci traccianti gli servono per orizzontarsi meglio e perciò riprende fiato.
È una storia nella storia che lo trascina lontano dalla terribile realtà ma non fa neppure a tempo ad abituarsi quando dinanzi a lui una sequenza di esplosioni si rincorrono senza soluzione di continuità: un bagliore segue ad un altro con terrificante immediatezza e tutto si illumina come un’immensa torcia. Avviene tutto dinanzi a lui, grida di dolore si aggiungono ad altre grida di dolore e poi, in un attimo, tutto finisce.
È come se il buio si accartocci su se stesso in una straordinaria nube di nebbia e solo allora sente il grido di richiamo di S. Ha un sussulto e capisce che cosa è accaduto. Deve agire subito ma non riesce a districarsi in un così denso labirinto di ombre su ombre ed infine. Davanti a sé dall’altra parte della vallata vede una piccola luce, che si muove disegnando un cerchio luminoso.
È S. che segnala la sua presenza e sa che deve raggiungerlo: ha fatto qualcosa che ancora non capisce ma sa che è lui che chiede collaborazione e non può più contenersi. Deve muoversi, dà un ordine concitato e due dei suoi soldati più vicini lo affiancano e si mettono ai suoi ordini. Capisce che deve far presto, che non deve essere preceduto dal nemico. Lascia in breve delle informazioni e si muove in compagnia dei due uomini.
Finì così la storia, una storia sbalorditiva che mi fece sentire piccolissimo nei confronti di un uomo che era riuscito a vincere se stesso, la paura, ed il senso stesso della morte. Gli altri personaggi che compongono il nucleo non meritano di essere citati, anche se sono reduci da diverse zone di guerra.
La loro eterogeneità forse darebbe adito ad un discorso sgranato e sfaccettato da personalità diverse ma non preminenti e non vale la pena neppure di cominciare. Forse nel prosieguo del racconto potrebbe presentarsi l’occasione per dedicare uno spazio per qualcuno di loro.
Tutto resta fermo
Sul fronte delle notizie si verificò proprio quello che io temevo di più: non mi fu concesso di prendere altri locali più dignitosi ed invece mi capitò fra capo e collo una rabbuffata del colonnello comandante, di quelle che difficilmente si possono dimenticare, e che mi fece ricordare che ero rimasto solo, con un reparto che conoscevo pochissimo, sufficientemente “scalcagnato” nel fisico e nella mente. Ero purtroppo lontano da tutti coloro che avrebbero potuto aiutarmi e neppure libero di prendere decisioni autonome, come, invece mi avevano assicurato.
Il reparto risultava smembrato là dove avrebbe dovuto essere unito e compatto proprio per le caratteristiche di impiego immediato in caso di necessità. Comunque dalla mia avevo per fortuna un carattere abbastanza deciso e sempre pronto ad aggirare l’ostacolo come in una buona tattica di guerra, almeno così mi avevano insegnato.
Poi il caso mi aiutò a migliorare la situazione anche se per i locali non se ne parlò più. L’occasione mi fu data da una esercitazione che mi andò benissimo contro le stesse aspettative di chi l’aveva chiesta ed organizzata. Malgrado le difficoltà logistiche fummo pronti in pochissimi momenti ed il reparto fece faville e creando nel colonnello comandante l’idea che addirittura ci fosse stata una soffiata tale da farmi trovare pronto con tutto il reparto.
La verità era che malgrado tutto ero stato, con l’ausilio del reparto scalcagnato, molto bravo ad organizzare le sequenze in tempi minimi di tutte le operazioni necessarie per attivarci in una non improbabile richiesta di impiego.
Non mancarono certo gli screzi: Il furiere, svegliato di soprassalto e non avendo servizi che soddisfacessero le sue esigenze fisiologiche, dopo aver socchiuso la porta credette di pisciare sulla strada ed invece…. bagnò gli stivali del colonnello che stava lì per origliare ed indovinare che cosa si stesse per fare.
Dette un certo fastidio anche la lettura del motto che avevamo affisso proprio sul muro dietro alla mia scrivania «Cca’ nisciuno è fesso.»
Un altro contrattempo, credo ancor più grave, fu quando il piantone uscendo di corsa ancora nel buio per venire a chiamarmi ed a darmi notizia dell’esercitazione si imbatté in una figura non meglio identificabile che voleva saper dove andava. Allora, infastidito dal fatto che gli faceva perdere tempo e dalla volontà di mantenere segreto il tutto, rispose con estrema semplicità «E che te ne fotte?» e si buscò un sonoro ceffone che poi, grazie al mio savoir faire non fu oggetto di reclamo. È superfluo chiarire che la “figura” era proprio il colonnello.
Da quel momento le cose cominciarono a volgere per il meglio: avemmo gli elogi, elogi che furono anche trasmessi al comando di divisione, io fui finalmente invitato alla mensa degli ufficiali, mi fu permesso di completare il pieno di gasolio per l’autocarro in dotazione ed il pieno di benzina per la motocicletta Guzzi 250 in dotazione per il porta-ordini.
Io, per completare le notizie, cominciai ad essere invitato a partecipare alle visite di controllo che il colonnello faceva ai reparti sotto il suo comando. Fu una delle occasioni che mi permisero in poco tempo di conoscere la zona di territorio che era stata affidata alla mia sorveglianza in un tempo direi da record. Infatti tutte le volte che ne sentiva la necessità, il colonnello mi mandava a chiamare per poter ispezionare i vari reparti distribuiti su tutto il territorio, che andava da Marina di Ragusa a Pozzallo, dipendendo poi dal Comando della 206a Divisione costiera a cui era affidato il tratto di costa tra Cassibile e punta Braccetto. Complessivi 132 Km: una enormità di spiaggia che avrebbe dovuto essere difesa contro l’eventualità di uno sbarco in forze degli Alleati.
Io, per la verità, non mi ponevo questi problemi: mi interessavano quelli più spiccioli, come le condizioni di vita, l’armamento, la profondità delle difese che nella realtà non esisteva limitandosi la linea ad un primo allineamento neppure coperto del tutto e qua e là una seconda linea di copertura molto espansa e raggruppata in piccoli centri operativi con postazioni di mitragliatrici pesanti in quote diverse dalla prima.
Mi interessava moltissimo anche l’elemento umano che a prima vista lasciava moltissimo a desiderare essendo composto da elementi provenienti da varie zone di guerra ed in modo particolare dalla zona greco-albanese che avevano dovuto lasciare per condizioni fisiche precarie in modo particolare per principio di congelamento agli arti.
Con uno sguardo più approfondito ti accorgevi che i depositi di vestiario non facevano grossi sacrifici per vestire bene i militari soprattutto per le calzature che mostravano evidenti segni di stanchezza. Molti soldati portavano ai piedi scarponi con tacchi consumati e con fasce che mostravano evidenti segni di sbrindellature.
Mi fu facile dedurne un parallelismo fra quello che vedevo e la situazione del mio reparto che lasciava a desiderare e non solo da quel punto di vista . La dislocazione così come era, faceva acqua da tutte le parti soprattutto nel caso di un impiego effettivo. Un nucleo antiparacadutisti a cui si richiedeva prontezza di impiego, informazione immediata, conseguente individuazione dei luoghi su cui intervenire, considerevole volume di fuoco che potesse contrastare, non dico alla pari, ma almeno per potere neutralizzare o bloccare forze paracadutate con una potenza di fuoco sulla quale non avevamo alcuna informazione ma che immaginavamo essere imponente, non lasciava grandi speranze di contrasti positivi.
Poteva essere un vantaggio la perfetta conoscenza dei luoghi a cui pensavo di poter pervenire attraverso le ricognizioni che i viaggi fatti con il colonnello comandante mi consentivano. In seguito perfezionavo queste mie visite guidando il reparto ed esaminando, sul posto, ogni possibilità con il contributo dei veterani che, come ho detto in altri momenti, esistevano nel Nucleo.
Tutto questo faceva parte di tante piccole esercitazioni che giornalmente organizzavo con la collaborazione dei miei due sottufficiali. Lo stato morale non mi sembrò basso anche perché si sapeva molto bene che altre zone di guerra erano ben più terribili e pericolose.
Di costruzioni difensive ne vidi ben poche oltre quella costruita al quadrivio Ragusa-Marina di Ragusa e Scicli- Santa Croce Camerina, dove i passaggi dei veicoli erano indiretti e sorvegliati da sentinelle che però avrebbero potuto impedire infiltrazioni di elementi isolati e nulla più: le forze presenti non potevano che sottolineare una presenza e soltanto una presenza.
Vidi qua e là postazioni che avrebbero dovuto nascondere nidi di mitragliatrici pesanti o di cannoncini anticarro che, per quello che mi risultò, dopo non vennero presidiati mai anche perché, come mi venne da considerare dopo, la loro mimetizzazione era assolutamente nulla e sembravano più un facile riferimento per chi avesse voluto colpirli.
Insomma, la cosa non mi piaceva tanto, pur non avendo ancora una cognizione precisa di come avrebbero dovuto essere. Mi colpiva il fatto che non si confondessero con il paesaggio circostante e che, per contro, si vedessero da posizioni anche lontane.
I miei piccoli viaggi continuarono per molto tempo per cui, ad un certo momento, potevo affermare di conoscere sufficientemente tutto il territorio a me assegnato.
Ci furono frequenti movimenti nei presidi delle varie armi soprattutto per quelli dell’artiglieria. Infatti scomparvero dalla circolazione quasi tutte le sezioni esistenti nella zona di Scicli. Dove fossero andate a trasferirsi non mi fu dato di saperlo ma io ero ottimista e non dubitavo minimamente che i comandi superiori ne sapessero più di me ed ubbidissero a piani precisi ed adatti alle circostanze. Il presidio militare a Scicli si ridusse ad una compagnia che avrebbe dovuto servire a dare il cambio,periodicamente ad altri reparti similari come alternativa di riposo.
Ci recavamo più spesso a Donnafugata da dove si sentiva facilmente l’odore del mare – di cui avevo una grande nostalgia – ed incontravamo gli altri militari che vi si trovavano di stanza e con i quali scambiavamo i nostri discorsi che spessissimo non si allontanavano dal pensiero delle famiglie.
Avevo fatto la conoscenza di altri due sottotenenti con cui avevo in un certo senso familiarizzato. Loro si lamentavano della monotonia della vita che li costringeva ad un isolamento a cui non riuscivano a porre rimedio. D’altra parte era questo il difetto di quella vita: non offriva diversivi ma che comunque preservava dai pericoli che in ogni altra parte del mondo esistevano ed esistevano in prevalenza.
Era in realtà un tran-tran stucchevolmente monotono che però non mi riguardava perché per un motivo o per un altro io, personalmente, avevo il mio da fare. Infatti avevo trovato un punto della città che mi consentiva una buona posizione per scrutare un orizzonte più ampio e vi avevo posto un punto di osservazione con degli uomini del Nucleo con il compito preciso di riferire qualunque cosa potesse verificarsi.
Il problema era sempre lo stesso, quello cioè della rapida comunicazione: non avevamo altro mezzo che quello che rese famoso il maratoneta delle Termopili!
Spesso partecipavamo a delle esercitazioni collettive insieme ad altri reparti. Dopo una di queste, a causa dell’assenza dell’ufficiale addetto alle relazioni, fui pregato di redigere una relazione della esercitazione completa e delle considerazioni che ne scaturivano. La mia aderenza quasi perfetta alla realtà e la descrizione cronometrica dei fatti fecero emergere delle manchevolezze che non mancai di evidenziare. Pensavo di aver azzardato troppo anche perché l’esperienza mi aveva insegnato che il «Tutto va bene, madame la marchesa» era più appropriato a quel genere di relazioni.
La cosa fece un po’ di scalpore e fui chiamato a rapporto dal colonnello comandante e quindi accompagnato alla presenza del generale di stanza in quel di Modica che aveva voluto conoscere il rivoluzionario dei metodi descrittivi. Io pensavo che, come spesso succede in queste occasioni, le rabbuffate vengono sempre a cadere sul più piccolo con un crescendo sempre più animoso quanto più numerosi sono i passaggi a scalare. Contrariamente alle mie previsioni ebbi delle felicitazioni e dei vivissimi complimenti che si trasformarono, purtroppo, in un maggior carico di lavoro: mi fu dato l’incarico non ufficiale ma ugualmente definitivo delle relazioni di qualunque tipo. Mi si davano degli appunti, dei riferimenti ed io dovevo metterli insieme ragionevolmente e secondo realtà. Per altro “ lo scrivere” era il mio mestiere, essendo laureato in lettere e presupponendo che sapessi mettere insieme per lo meno una ventina di parole.
Andamento lento
Successivamente ebbi altri incarichi, come quello di prelevare settimanalmente le parole d’ordine per tutti i reparti. Dapprima andavo a Modica, sede del Comando di Divisione servendomi del treno, ed in seguito, poiché cominciavano ad essere frequenti i mitragliamenti degli stessi ad opera dei caccia alleati, fui pregato di andare in moto nella speranza che la strada riservasse una maggior sicurezza.
Per timore di diventare io stesso un facile bersaglio ed in considerazione che fosse impossibile avvertire qualunque rumore di aereo in avvicinamento a causa soprattutto del fracasso inevitabile della stessa motocicletta, decisi di adottare un sistema che speravo potesse funzionare. Io alla guida ed il mio motociclista seduto in senso contrario alla direzione di marcia, in altre parole schiena contro schiena, con il preciso incarico di osservare a trecentosessanta gradi il cielo per tutto il suo orizzonte. Speravamo in questo modo di avere almeno il tempo di toglierci dalla strada in caso di pericolo.
Fortunatamente non ci fu mai bisogno di un ripiego del genere, anche se non era difficile che accadesse poiché già in altre occasioni erano stati mitragliati carretti o addirittura contadini che andavano o tornavano dalla loro campagna. Lo scopo era evidentemente quello di rendere insicuro qualunque movimento, soprattutto dei reparti.
Non mi ritenevo certo un eroe a portare a termine il servizio affidatomi ma era certo che mi guardavano con molta simpatia quelli che avrebbero dovuto assolverlo. Penso che il sentimento predominante era dovuto ad uno mio stato di pura incoscienza e ad un senso di sfida a qualunque non improbabile eventualità.
Un bel giorno accadde che un caccia tedesco precipitasse dopo una sua incursione su Malta. L’aviatore non potè abbandonare l’aereo e cadde in mare a un centinaio di metri dalla spiaggia. Un nostro ufficiale assistette alla scena e non esitò a buttarsi in acqua, così vestito come era. Riuscì a condurlo fino a terra malgrado l’appesantimento del paracadute bagnato. Il tenente ebbe dei riconoscimenti persino dai comandi tedeschi: addirittura lo insignirono di una medaglia.
Con molta sorpresa si seppe che lo stesso conosceva la lingua tedesca e pertanto per avere un interprete a disposizione fu disposto il suo trasferimento presso il comando di reggimento. Credo che per lui, in quel momento, valesse di più il trasferimento che la stessa decorazione.
Quello fu il periodo in cui l’aviazione sia italiana che germanica bombardarono sistematicamente l’isola di Malta: tutte le sere, subito dopo il tramonto, il rumore cupo ed intenso delle formazioni aeree annunziava per parecchio tempo le incursioni.
In quelle occasioni l’orizzonte si illuminava di bagliori straordinari dopo pochi minuti dal passaggio degli aerei, e si avvertivano i rumori delle esplosioni attenuati dalla distanza. Immaginavamo l’inferno di fuoco che si abbatteva sull’isola come un’apocalisse e la pelle ci si accapponava. Pensavo che ciò potesse avvicinare la fine della guerra anche per le considerazioni che i bollettini ufficiali ci suggerivano e naturalmente in modo positivo per noi. Occupando l’isola, molti problemi per il collegamento con la Libia si sarebbero certamente risolti.
Il bombardamento di Malta continua
Il bombardamento di Malta si protrasse per tutto il mese di aprile e proseguì anche per molta parte del mese di maggio. Sembrava che la difesa contraerea dell’isola si affievolisse sempre di più ma ad un certo momento le incursioni si fecero più rade e la testimonianza luminosa dei riverberi degli incendi diminuì fino al punto di estinguersi completamente.
Le cose in Africa settentrionale, così come dicevano i bollettini di guerra, andavano nel complesso abbastanza bene: qualche arretramento, qualche riconquista e successiva stabilizzazione. Andavano maluccio i rifornimenti e certe soste erano obbligate dalla mancanza di benzina.
Infatti i nostri convogli stentavano a portare a destinazione truppe, carri, benzina e rifornimenti di ogni genere. Sembrava che i bombardamenti su Malta fossero suggeriti dalla necessità di neutralizzare la base di partenza di tutti quei mezzi che impedivano l’arrivo in Libia dei nostri rifornimenti a mezzo dei convogli navali.
Con i bombardamenti dell’isola di Malta e quindi con la sua neutralizzazione le nostre navi cominciavano a camminare più spedite e più sicure, ma quando non si sentirono più i tuoni ed i fragori dei grandi scoppi la logica dei nostri ragionamenti cominciò a vacillare ed invece si moltiplicarono gli interrogativi.
Erano o non erano utili i bombardamenti? Le cose andavano sempre bene? C’era qualcosa che non andava che noi non capivamo e che non potevamo capire?
Eravamo in uno stato di nervosismo e di allerta che sembrava non avesse fondamento se non nelle nostre preoccupazioni, non si sapeva bene quanto fondate.
In una notte di grande plenilunio fu dato l’allarme a tutta la zona: tutti i reparti furono bloccati nelle loro sedi ma pronte ad intervenire sul territorio. Non si seppero i particolari, ma il mattino successivo, cessato l’allarme, fui chiamato al comando di reggimento per redigere un rapporto di cui mi furono dati i particolari.
Venni a conoscere così la motivazione: su un gommone erano sbarcati sulla spiaggia tre ufficiali della marina inglese ed erano stati immediatamente catturati. La relazione, quasi stenografica, partì subito per i comandi superiori mentre gli ufficiali furono condotti al Comando di Reggimento. Non risposero a nessuna delle domande loro rivolte per cui rimase sempre un mistero se provenivano da una imbarcazione militare affondata, se facevano parte di un commando con precisi obiettivi di incursione o di informazione sul nostro territorio.
Mi sembrarono molto ben puliti per essere dei naufraghi e per contro erano abbastanza soddisfatti e dal loro atteggiamento anche molto altezzosi. Ripetevano come una litania i loro nomi e cognomi ed i loro numeri di matricola, almeno così a me parve per una sequela di parole che sembravano più una enumerazione che un discorso con significato compiuto: io non capivo neppure una parola di inglese.
Non erano armati e la cosa non era normale per degli ufficiali e non avevano neppure una carta topografica che facesse pensare a degli obiettivi che dovessero raggiungere. Nella perquisizione furono sequestrati loro dei fazzoletti con sopra stampata la carta geografica della Sicilia.
Quel che facevano capire e frequentemente ripetevano era la frase «Italia presto caput». Sembrava che non capissero affatto la lingua italiana ma io ero convinto che fingessero in considerazione del fatto che in genere tutti gli ufficiali di Marina conoscevano molte lingue ed anche molto bene. Inoltre stavano molto attenti quando noi italiani parlavamo intorno a loro facendo con estrema faciloneria tutte le considerazioni che ci venivano in mente, anche quelle che avrebbero potuto far loro comodo.
Furono per contro rifocillati convenientemente e invitati a riposarsi su comode poltrone. Si discusse, e questa volta in disparte, lontano dalle loro orecchie, della sorveglianza, che opportunamente per degli ufficiali doveva essere eseguita da ufficiali.
Io, onestamente, ignorando quello che avevano in mente e quali fossero i loro disegni, almeno prima dello sbarco, e per evitare qualunque sorpresa li avrei fatti sorvegliare da alcuni militari anche ben armati e pronti ad ogni evenienza, ma gli ordini erano ordini e così toccò a me fare il primo lunghissimo turno che feci con grandissimo scrupolo: erano dei nemici e la loro spavalderia non mi piaceva affatto.
Rimasi tutto il tempo con gli occhi sbarrati e con la pistola in pugno pronta a sparare, con la sicura tolta e con il colpo in canna. Non avevo alcun desiderio di colloquiare ma neppure loro mostrarono di averne anche perché si addormentarono presto pur nelle loro scomode posizioni.
No, non ero affatto sicuro delle loro buone intenzioni: erano dei nemici e questo bastava perché li guardassi in cagnesco senza un minimo di comprensione. Le loro famiglie? L’avevo anch’io. La loro vita ? Non si confaceva affatto con la mia, in un certo senso valeva più della loro e personalmente non ero andato a scomodarli fin dentro la loro casa.
Era un ragionamento semplicistico, non valido, oggi lo so, ma allora ed in quel momento i miei pensieri erano quelli.
Il giorno successivo giunsero al comando di Reggimento degli ufficiali tedeschi per prelevare i prigionieri. Al comando nacque un po’ di confusione: nessuno parlava la lingua tedesca dopo che l’ufficiale che la conosceva e di cui ho raccontato prima, non si era comportato bene ed era stato rinviato in servizio sulla spiaggia. D’altra parte nessuno degli ufficiali tedeschi giunti al presidio sapeva parlare la lingua italiana.
Io, per altro non avevo fatto sapere che conoscevo il tedesco un po‘ per timidezza, un po’ perché non mi ritenevo abbastanza sicuro, molto perché non c’era mai stata l’occasione di mettermi in evidenza. L’unica occasione che si era presentata fu quando l’aviatore tedesco fu portato in salvo e, guarda caso, colui che lo fece mostrò di essere abbastanza in gamba per colloquiare nelle due lingue.
Fu dunque il caso che mi dette l’occasione: ero anch’io al comando quando notai che il colonnello era nervosissimo perché non capiva il motivo della visita dei tedeschi né sapeva che cosa rispondere. Fu dunque molto naturale per me radurre al colonnello le richieste fatte e quindi trasmettere quanto il colonnello stesso volle far sapere.
In effetti volevano in consegna gli inglesi e per questo avevano dei documenti firmati dai comandi superiori italiani insieme a quelli tedeschi. Il tutto era chiaramente indicato e scritto in lingua tedesca per cui a me fu molto più facile leggere e tradurre. Il perché è facile dedurlo dal fatto che il mio studio e la mia pratica si era soffermata più sulla lingua scritta e meno sulla lingua parlata.
La soddisfazione fu grande da ambedue le parti e presto si giunse alla consegna dei prigionieri che interessavano moltissimo ai tedeschi che certamente avevano più mezzi di noi e meno umanità per farli parlare.
Finalmente partirono e li seguì una scorta dell’esercito su due lunghi mezzi per il trasporto truppa. Tutto finì nel miglior modo possibile meno che per me, perché dovetti dare mille spiegazioni sul non aver fatto sapere prima la mia conoscenza del tedesco. Alla fine non ebbi degli elogi ma solo dei rimbrotti che però a me sembrarono affettuosi e mi fu possibile risalire un gradino più in alto nella stima e nel rispetto di tutti.
In effetti non avevo fatto altro che seguire una mia filosofia, tramandatami da mio padre: stava a me far conoscere i miei difetti prima che li scoprissero gli altri. Che questi ultimi avessero poi la possibilità di venire a saper delle mie “virtù” solo al momento opportuno e senza alcuna spinta da parte mia.
Comunque, a Scicli la vita trascorreva sempre uguale: piccole escursioni durante i giorni feriali, lunghe passeggiate, di domenica, sulla piazza della Chiesa Madre dove si raccoglievano quasi tutti i paesani vestiti a festa.
Gli ufficiali facevano la loro comparsa con le famiglie, che, potendo, li avevano seguiti. Ragazze molto poche. Venivano in paese per l’occasione domenicale anche le famiglie facoltose che si erano trasferite nelle ville di campagna, e dopo aver ascoltato la Messa andavano a consumare le suole delle scarpe in lunghissime oltre che noiosissime passeggiate sulla piazza.
Qualche incontro era possibile soltanto allora, tuttavia sempre restando nella propria cerchia: i paesani con i paesani, la noblesse con la noblesse, “l’esercito con l’esercito”.
Intanto anche in quelle occasioni ebbi modo di notare che la presenza dei militari a Scicli si assottigliava sempre di più. Insomma, voglio far intendere a me stesso che probabilmente nei piani di carattere militare, generalmente parlando, la zona dovesse essere ritenuta sempre meno importante.
In compenso cominciarono a sfrecciare sulle nostre teste e solo per qualche istante aerei inglesi e canadesi. Forse la zona era valutata molto meglio dai nostri nemici che però trovavano sempre più, in assenza di nostre difese contraeree, la facoltà di roteare sulle nostre teste con maggiore frequenza, essendo, credo, aumentata la facilità di essere presenti sul territorio.
Evidentemente Malta aveva ripreso positivamente il ruolo di sentinella del Mediterraneo dopo essersi scrollata dalle spalle l’infernale serie di bombardamenti italo-tedeschi. In quelle occasioni accadde che anche la radio di Malta facesse sentire meglio e più forte la sua voce. Di buon mattino era facile ascoltare una voce che si appellava ai comandanti dei nostri reparti perché rendessero sempre più facile l’imminenza di un amichevole incontro fra le nostre truppe e quelle della prossima invasione.
Noi, nei nostri commenti, arrivavamo persino a ridere ed a gongolarci tutte le volte che venivano fatti i nomi, i cognomi dei comandanti di compagnia, di battaglione e perfino di plotone dei reparti dislocati lungo tutta la fascia costiera. Insomma non perdemmo mai la nostra tranquillità finché, un giorno…
Sì, un giorno eravamo nell’ufficio del comando di reggimento in attesa che giungesse. Alcuni di noi sostavamo sul balcone quando improvvisamente un rombo di aerei, più forte del solito, ci costrinse ad alzare gli occhi al cielo: era una squadriglia di cacciabombardieri scintillanti al sole.
Ad un tratto uno di essi cominciò a sfarfallare: era il segnale che temevo e per il quale gridai che stavano bombardando. Non fui creduto al momento, ma quando cominciarono ad esplodere le prime bombe fu un fuggifuggi generale. Cercammo di raggiungere il seminterrato ma prima che potessimo percorrere la serie di stanze che ci dividevano dalle scale di marmo e successivamente al piano di sotto, il bombardamento finì.
Mi tolsi a fatica di dosso la persona che si era aggrappata alla mia divisa e che si era afflosciata sulle gambe e corsi giù per la strada con il preciso intento di raggiungere il mio reparto. Lo ritrovai raccolto, terribilmente stravolto ma senza nemmeno una perdita. Una fortuna, considerando il fatto che quella era stata la zona scelta come bersaglio degli aerei.
Ci consultammo brevemente per il successivo momento di azione mentre tutte le persone ed i civili in particolare cominciarono a sciamare per le vie in preda al terrore. In questo frangente un aereo da caccia a bassa quota cominciò un crudelissimo mitragliamento che fece una terrificante carneficina. Le vittime non si contavano più. I feriti, alcuni stesi per terra in un lago di sangue gridavano aiuto ,altri non potevano più farlo perché rimasero immobili ed i soccorritori, fra cui noi del Nucleo, non poterono che constatarne la morte.
Ai miei occhi una straordinaria e terribile immagine da monumento dei caduti: un gruppo di cinque soldati di cui due seduti e tre in piedi dietro ai primi ancora con le gavette in mano bianchi di polvere e soprattutto di morte erano stati colti così in una macabra foto di gruppo. Non avevano bisogno di aiuto, ormai, ma ne avevo bisogno io che per la prima volta mi ero trovato di fronte ad una morte che non riuscivo ad intendere, che mi sprofondava in una realtà che ancora non avevo conosciuto e che mi toglieva il respiro, mi spezzava l’anima, infrangeva in un attimo tutte le mie speranze.
Guardavo in viso gli altri e trovavo in loro l’espressione che immaginavo di avere io stesso. Vedevo incredulità, pensavano che forse non era giusto che ciò accadesse ed allo sbigottimento subentrava l’inizio di un terrore infinito. Che cosa succederà domani ? è questa la fine o l’inizio di una tragedia a cui non osavamo pensare?
E tutti noi, ciascuno di noi, soli in mezzo a tanti, soli con la propria sorte, soli con la propria tragedia che suonava a morte come le campane di una chiesa immensa, grande quanto il cielo, quanto l’universo.
Ognuno di noi era solo dinanzi allo specchio della realtà che in quel momento stavamo vivendo. E le nostre famiglie? La mia famiglia? Perché era tanto lontana? Perché si trovava al di là di un abisso che allora sembrava non dovesse mai colmarsi? Perché, insomma, mi trovavo là, in una situazione più che disperata, di fronte anche alla impossibilità di reagire, di fare cioè qualcosa che potesse almeno tirarmi fuori da quello che certamente mi avrebbe riservato il futuro?
Ma le sensazioni restano nitide e precise nei contorni e nelle sfaldature rese ancora più drammatiche dal terrore che ti suonava all’interno delle tue viscere come i colpi sordi di un martello che faceva pulsare i tuoi polsi, le tue tempie il tuo essere sperduto nella solitudine di una immensa marea umana che si muoveva nella tragedia di una guerra di cui sapevi ben poco, anzi non conoscevi affatto soprattutto nei suoi perché, nelle sue ragioni profonde e meno profonde.
Occorreva muoversi ed io mi mossi dapprima come un ubriaco poi, a poco a poco, un po’ più cosciente. Il mio reparto diede l’aiuto che tutti si aspettavano: una volta superato lo sbalordimento fu una corsa al soccorso di coloro che ne avevano bisogno. Ed erano tanti, tanti. Che tragedia!
Il reparto trovò successivamente ricovero in una grotta vicinissima al nostro posto di osservazione, a ridosso della collinetta che sovrastava la posizione di Scicli.
Per alcuni giorni ci fu possibile usufruire del punto di osservazione che ci eravamo creato per poter traguardare su tutto l’orizzonte ma poi venne l’ordine di lasciare libero il posto per potervi installare una mitragliera contraerea da 20 mm per la difesa del paese.
Ormai, così come la chiesa di Santa Chiara era stata derubata ma, comunque, non fu troppo tardi: passarono soltanto pochissimi giorni ed una pattuglia di caccia-bombardieri si fece viva ad altissima velocità. Avvertimmo subito il rombo dei motori in picchiata e poi una lunga sventagliata di mitraglia pesante e quindi una lunghissima fumata nera verso il basso.
Uno degli aerei, colpito, precipitò senza scampo: anche questa volta il Nucleo fu il primo a raggiungere l’apparecchio abbattuto e ci trovammo dinanzi ad una realtà sconvolgente: non lontano dall’apparecchio c’era il corpo del pilota che era appena riuscito ad evadere dalla carlinga ma che non era riuscito a far aprire il paracadute, quindi giaceva in modo innaturale schiacciato sul terreno, sfigurato dal tremendo impatto ed assolutamente irriconoscibile.
Un primo importante problema da risolvere fu quello di impedire alla folla che sopraggiungeva infuriata di raggiungere il corpo del pilota. Dovemmo opporci in modo brusco e forte a che qualcuno di loro potesse giungere a compiere un misfatto di inaudite proporzioni: non sarebbe stato un linciaggio ma una terribile profanazione.
Ormai la guerra con le sue terribili realtà era a noi vicinissima e cominciavamo ad avvertirne i gravi sintomi come di una febbre altissima che pervade senza respiro tutto il corpo e soprattutto la mente.
Il nostro esercito insieme con quello germanico cominciò ad arretrare definitivamente dalla Libia e “per meglio difendersi“ si arroccò in Tunisia invadendo un altro Stato.
È vero che avevamo perduto la nostra più apprezzata colonia, ma è anche vero che avevamo conquistato un altro paese dal quale avremmo certamente potuto difendere meglio le nostre posizioni.
Questa volta però non avremmo dovuto opporci soltanto alle armate di Montgomery ma anche a quelle americane che nel frattempo,sbarcate nel Marocco, andavano man mano attestandosi dalle parti dei confini tunisini.
Dalla Russia cominciavano a trapelare notizie per noi burrascose e le armate germaniche, fino a quel momento invincibili ed invitte, cercavano linee di difesa più ristrette e più vicine alle basi di rifornimento.
Si sapeva poco della nostra armata ,quella che avrebbe dovuto partecipare alla grande marcia trionfale su Mosca e quindi sugli Urali e sul mar Caspio. Guardando la carta geografica vedevi questa grande tenaglia che si stringeva da una parte dall’Egitto e poi sui paesi arabi del Medio Oriente, oltre la Turchia fino al Caucaso, e dall’altra, superata la barriera caucasica. fino alla zona montuosa dei Curdi.
Mi pare, attraverso i ricordi di scuola, che un sogno simile fosse vagheggiato da Alessandro il Macedone. C’era soltanto una piccola differenza: Alessandro lo realizzò sul serio e felicemente, noi, noi no.
Clima di drammatica vigilia
A Scicli la federazione fascista si mobilitò in previsione di una chiamata alle armi per una difesa ad oltranza, casa per casa, e rastrellò un certo numero di “inabili” per istruirli all’uso delle armi.
A me, sinceramente parve una contraddizione fra l’affermazione che nessuno avrebbe potuto calpestare il suolo della madre-patria e la corsa alla mobilitazione di un sempre piccolo gruppo di persone che mi apparivano assolutamente inabili all’uso di qualunque arma, persino di un manico di scopa.
Lo sperimentai a mio rischio e pericolo quando, chiamato ad istruire il gruppo di loro sul lancio delle bombe a mano, mi vidi lanciare contro, io che stavo dietro al lanciatore, uno di quegli arnesi esplodenti. Fu un attimo, ma in quell’attimo vidi tutto ed il contrario di tutto: nello stesso tempo in cui la bomba percorreva in aria la sua parabola ascendente e discendente feci quello che solo si poteva fare, mi buttai a terra mentre l’esplosione lanciava in verticale frammenti di bomba, di sassi e di terra. Rimasi vivo ma mi vidi soccorso da tutti coloro che non avevano ben capito se fossi caduto per effetto della bomba o per effetto del mio spirito di conservazione.
In quella occasione, nel recuperare le bombe rimaste inesplose, l’ufficiale artificiere che mi accompagnava fu colpito ad un occhio, fortunatamente senza gravi conseguenze, da una piccolissima scheggia impazzita. Occorreva pur pagare un obolo a quella insulsa operazione di “guerra”.
Facemmo un’altra esercitazione per prepararci ad un eventuale sbarco con una azione in grande stile sull’ipotesi di una infiltrazione di truppe sbarcate ed avanzate oltre la linea della spiaggia. Fummo mobilitati tutti, compreso il mio reparto, che fu impegnato al di fuori del suo compito su una collina ai limiti perimetrali del paese.
A sera inoltrata dovetti segnalare con un colpo sparato dalla pistola Very che non c’era nulla di nuovo e che saremmo tornati alla base dopo aver avuto riscontro con un altro razzo che vedemmo saettare nell’’oscurità. Il giorno dopo avendo a disposizione tutte le notizie dei reparti che avevano partecipato all’esercitazione, redassi una lunga e circostanziata relazione.
Per la mia parte scrissi che, calata la sera, non vedevamo al di là del nostro naso e potevamo muoverci soltanto accendendo dei fiammiferi, cosa che però non facemmo perché avremmo dichiarato la nostra presenza. L’osservazione non ebbe alcun riscontro e non fummo mai forniti di torce o di qualunque altra fonte di luce: evidentemente saremmo stati impiegati in ogni caso soltanto di giorno.
Per qualche tempo non si registrò alcunché di nuovo se non nell’animo di ciascuno di noi che subì l’influsso malefico di un qualcosa di indefinito che ci faceva stare con i nervi completamente tesi ed in uno stato di allerta che non sapevamo meglio definire ma che certamente era determinato dalle vicende negative che andavano concretizzandosi sempre più nere sui vari fronti di guerra.
Per i nuclei antiparacadutisti ci fu un momento di pausa determinato dall’organizzazione di un corso di aggiornamento da tenersi nella sede di Modica per tutti i comandanti dei nuclei stessi della zona e con la partecipazione di un gruppo di capitani appena richiamati alle armi, che sarebbero stati quindi smistati sul territorio per coordinare, ciascuno, un certo numero di nuclei. Fu quella un’inconsueta occasione per incontrarci dopo tanto tempo da quando eravamo partiti insieme dal Comando di Deposito del 3° Reggimento Fanteria.
Naturalmente, durante il corso, non apprendemmo niente di nuovo se non acquisire la certezza che avremmo perso molto della nostra autonomia in cambio di una diretta o quasi diretta sorveglianza di superiori che ancora non avevano acquisito la nostra esperienza e che certamente, non avendo una sede ben definita, sarebbero stati in ogni caso assenti da qualunque luogo ci fosse stato richiesto un impiego immediato.
Non ci fu data un’arma in più, non ci fu data alcuna informazione utile per conoscere meglio il metodo, l’armamento del nemico, non ci fu dato alcun segno premonitore di quello che ci sarebbe certamente accaduto, purtroppo in un futuro non più lontano.
In quella occasione non volli perdere l’abitudine di dire quello che pensavo e così non potei acquisire le simpatie dei nuovi superiori che si sarebbero certamente interposti fra quelli che già possedevo e che mi ero conquistati non senza qualche sacrificio.
In tutti i modi non potevo assolutamente prevedere quello che sarebbe accaduto nel brevissimo tempo a venire
Trasferimento a Ragusa
Ragusa è un capoluogo di provincia situato sui monti Iblei a 502 m. di altitudine. Ha circa 60.000 abitanti ed ha caratteristiche eminentemente agricole. Posto, come dicevo, sui monti Iblei su un declivio fortemente pronunciato come su una lunga lingua di terra degradante fino a Ragusa Ibla. Era un importante punto strategico dove convergono le strade da Modica, Marina di Ragusa, Comiso, Vittoria ed Acate.
Ero sull’attenti in attesa che il comandante della 9° sottozona a cui mi stavo presentando in attesa che mi concedesse il riposo. Ma il colonnello dei Carabinieri che, seduto dietro la sua scrivania, sembrava non essersi accorto della mia presenza non dava alcun segno di attenzione. Tuttavia io mi sentivo scrutato ed osservato ed infine qualcosa si mosse. Il colonnello si alzò, sembrò venirmi incontro ma invece di tendermi la mano mi rimbrottò violentemente perché indossavo pantaloni fuori ordinanza.
Fu come un pugno sul viso perché avevo fatto di tutto per apparire nel modo migliore curando in particolar modo la divisa. Mi venne il dubbio che qualunque cosa avessi fatto per fare bella figura il mio nuovo comandante diretto avrebbe trovato in qualunque modo un motivo per rimproverarmi. Era chiaro che sostituivo un comandante di Nucleo che, sapevo, lui stimava moltissimo e che, dunque, la mia presenza lo disturbava moltissimo Ritenevo che ciò fosse quasi giusto ma di sicuro non mi aspettavo una uscita di quella fatta.
Cominciavo proprio bene: era destino che tutte le mie nuove conoscenze fossero dominate da un accento fortemente critico nei miei confronti.
Ero partito da Scicli molto addolorato per la nuova destinazione che mi era stata comandata per fonogramma, ed era chiaro che il mio animo era del tutto esacerbato da un fatto inatteso, imprevedibile ed altrettanto indesiderato, dovendo lasciare un ambiente a me notevolmente favorevole, ove qualunque nota poteva essere interpretata soltanto con l’ affetto che tutti, dico tutti, provavano per me. Affetto che io ricambiavo con uguale intensità e sincerità nei loro confronti, superiori e non. Non avevo avuto modo neppure di esternare questi miei sentimenti se non verso qualcuno perché il provvedimento era stato proprio un capestro. Il giorno successivo al fonogramma ero già in marcia verso Ragusa con tutto il mio reparto e con gli automezzi che ci seguivano a distanza. perché con lo stesso fonogramma si erano preoccupati di vietarci l’uso dei mezzi per raggiungere la nuova destinazione.
Il fatto mi sembrò come un provvedimento disciplinare, ma chi lo aveva emesso? Non volli neppure pensarci, e permeato come ero di una forma di subordinazione al destino, sgombrai l’animo da qualunque pensiero negativo e cercai di guardare avanti con un certo ottimismo.
Ottimismo che fu anche necessario mostrare ai miei soldati che mostravano di essere più neri di me: forse avevano lasciato qualcosa che certamente non avrebbero più trovato in un nuovo ambiente.
E poi, perché, visto che dopo aver fatto tanto per conoscere nel miglior modo possibile il territorio e la cui conoscenza poteva costituire una prerogativa non trascurabile in un eventuale scontro con forze sicuramente più armate di noi ma che non avevano la conoscenza diretta del terreno su cui avremmo dovuto operare?
Perché nell’imminenza di un quanto mai probabile sbarco di paracadutisti si cercava di imbrogliare le carte in modo da metterci in condizione di ulteriore inferiorità?
«Mistero della ragione», pensai che non stava a me sindacare, che i superiori sapevano sicuramente quello che facevano o forse lo sapevano troppo bene e i miei dubbi riaffioravano, questa volta con una ragione in più. Non mi fu dato di sapere se lo stesso scambio di sede fosse stato preso anche per tutti gli altri nuclei. In caso negativo il soggetto-oggetto sarei stato proprio io e per quale ragione non si sapeva e nessuno lo seppe mai.
In ogni modo ero sempre li in attesa che l’esame a cui ero sottoposto finisse e con lui finissero i rimbrotti riservati, secondo il mio pensiero, a tutti coloro che dovevano conoscere che: «Qui comando io, intesi?»
Per queste considerazioni mi guardai bene dal riproporre all’entrata del reparto il detto che mi costò un sacco di improperie proprio nel momento del mio primo impatto operativo con il comandante di reggimento costiero: «Cca nisciuno è fesso”. Però non mi nascondevo, proprio in fondo all’anima, che quel motto corrispondeva a quello che c’era dentro di me, tanto nel cuore quanto nel cervello. E se guardavo bene negli occhi i miei soldati vedevo in fondo che quel mio pensiero, poi non tanto recondito, era condiviso.
Il “riposo” mi fu dato con un certo ritardo seguito da raccomandazioni da fare rizzare i capelli per la loro prevedibile severità e poi la minaccia: Domani verrò al reparto.»
Finalmente era giunto il momento di andar via: calzai la bustina, feci il saluto militare e con un perfetto dietrofront uscii dalla stanza. Trovai il mio motociclista che mi aspettava e via incontro alla libertà.
C’era proprio bisogno di un poco d’aria e la velocità del mezzo me ne fece un graditissimo compenso. Il viaggio di ritorno all’accampamento mi diede la possibilità di rilassarmi e di riacquistare la mia abituale tranquillità, o per meglio dire, quella tranquillità che ero solito mostrare ai miei soldati.
Quando giungemmo al reparto gli uomini erano ancora intenti a sistemare alla bene e meglio l’accantonamento ma tante cose non andavano, anche se finalmente avevamo lasciato una stalla-tugurio per una costruzione a misura d’uomo: era una vecchia scuola d’arte adattata ad accogliere un reparto di soldati. I problemi c’erano ed anche grossi e occorreva risolverli ma io non avevo alcuna voglia di affrontarli, almeno in quel momento, e pertanto li rimandai tutti al giorno dopo.
Fu invece il mio motociclista che mi rincuorò alquanto raccontandomi cose che diversamente non avrei mai saputo. Venendo al comando di sottozona, nel tempo in cui io ero stato trattenuto dal colonnello comandante, lui si era invece fermato a parlare con l’autista personale del colonnello. Si erano infatti riconosciuti perché entrambi di Ragusa e già conoscenti di vecchia data.
Ecco, in sintesi, quello che aveva saputo confermando, infatti, le mie supposizioni sullo stato d’animo del colonnello comandante: il tenente comandante il nucleo di stanza a Ragusa era entrato nella simpatia del comandante, godendo quindi di condizioni privilegiate dettate dalla stima e dall’affetto. Spessissimo andavano insieme a fare ricognizioni presso gli altri nuclei alla dipendenza della sottozona e pertanto si erano instaurate le migliori condizioni possibili per un reciproco rispetto.
Il dispetto ed il dispiacere della sua partenza era stato poi ulteriormente esacerbato dalla telefonata del colonnello comandante il reggimento costiero ai cui comandi ero rimasto per molto tempo che gli aveva presentato la mia persona come un ufficiale brillante ed all’altezza di ogni situazione. Dinanzi a tale dimostrazione si era ulteriormente indispettito e, posato il telefono, aveva esclamato quasi con rabbia: «Il colonnello mi vuol vendere gioielli falsi.” Fu così che la mia persona perse ogni caratteristica umana per abbracciare quella di oggetti di nessun valore o, ancor peggio, addirittura falsi.
Doveva andare proprio così: i mali non vengono mai da soli ed alla partenza dolorosa a cui ero stato costretto e di cui non ho mai compreso i motivi, diciamo, tattici o strategici si aggiungeva, allora, un trattamento di cui non mi sentivo affatto meritevole.
Tuttavia il pensiero che le soddisfazioni si conquistano sul campo mi incitò ad alzare la testa ed a guardare in faccia una realtà che in quel momento non mi era certamente favorevole. Alla fin fine era accaduto qualcosa che – almeno quella – non mi era sfavorevole. Il caso aveva voluto che, senza volerlo, avevo infiltrato una “talpa” nell’ufficio comando di sottozona.
Il giorno successivo il colonnello, così come aveva promesso, venne all’accantonamento ma non trovò niente in ordine anzi trovò che tutti, in una grande confusione, si davano da fare per rimettere a posto tutto quello che in un certo senso era stato in un primo momento messo a soqquadro. Una squadra si era data da fare per spazzare, lavare e pulire il pavimento delle varie stanze dove il materiale che avrebbe dovuto trovare sistemazione: era invece ammassato alla rinfusa in un disordine pazzesco.
Nel locale destinato alle cucine si era in un gran da fare per sistemare meglio i fornelli ed infine in un gran bidone che ci eravamo procurati erano stati messi a bollire le decine di teli delle brandine mentre le stesse parti in ferro erano state sottoposte al trattamento della nafta spennellata in maniera decisa e precisa dove necessario.
Che cosa era accaduto? Lo dovetti necessariamente spiegare al colonnello che non si rendeva perfettamente conto di ciò che stava succedendo e perché. La spiegazione fu molto semplice da parte mia e finalmente l’incipiente ira del colonnello si affievolì notevolmente: il fatto è che in una ricognizione neppure tanto attenta ci eravamo accorti che i lettini con materassi e tutto il resto erano infestati in maniera indecente da cimici per cui stavamo correndo ai ripari. Le bordure dei materassini erano addirittura nere per il gran numero di insetti. Non mi rendevo conto di come i soldati che ci avevano preceduto non avevano sofferto dell’invasione e non avevano sentito neppure la necessità di porre rimedio alla infestazione.
Comunque il colonnello cominciò ad ammorbidirsi e si distese del tutto quando facendogli vedere quello che stavamo facendo nella cucina, gli precisai che, per risparmiare combustibile – in questo caso la legna – stavamo predisponendo dei fornelli in sequenza in modo che il fuoco centrale servisse anche per gli altri fornelli prima di prendere il via nella canna fumaria. La cosa era molto semplice, ma parve impressionare benevolmente il comandante.
Cominciavo a segnare il primo punto a mio vantaggio. Se ne andò con un «Ci vedremo domani.» Mi sembrò piuttosto una mezza minaccia che una promessa. Secondo me il giorno successivo era ancora troppo presto.
Visite e controvisite
Il giorno successivo fu un giorno che definirei molto laborioso: I miei soldati si dettero un gran da fare per mettere a posto tutto quello che occorreva mettere al giusto posto nel modo più adatto e con grande effetto per colui che fosse venuto per la prima volta. Fu in questa grande attività che ci trovò il colonnello che, per la verità, rimase alquanto sorpreso nel vedere tutta la camerata allineata e coperta in tutto ciò che c’era dentro: i letti , i materassi arrotolati alla stessa maniera, le coperte con le strisce bianche perfettamente allineate, il pavimento risplendente e lucido come se fosse stata passata la cera.
Volle vedere l’armeria, e qui rimase veramente ammirato perché anche quelle apparivate pulitissime e allineate, come se fossero state appoggiate in apposite rastrelliere. Non disse nulla, non voleva ancora esprimersi perché forse pensava che ancora non era giunto il momento per mostrarsi soddisfatto. Compresi tuttavia la sua buona impressione dalla frase che pronunciò al momento di andar via. «Spero di vederti così anche all’opera sul campo.» Non era molto, ma a me fu più che sufficiente.
I giorni successivi furono impiegati ad addestrarci sui “Beretta 40” che ci avevano consegnato negli ultimissimi tempi: erano fucili a quaranta colpi che potevano sparare in rapida successione o a colpi isolati, aveva un unico caricatore per tutti i colpi ma presentava qualche piccolo difetto: doveva essere usato in piedi o in ginocchio perché il caricatore, molto lungo, avrebbe toccato per terra se si fosse voluto sparare sdraiati. Inoltre, presentava la possibilità che potesse mettersi a sparare da solo se fosse stato appoggiato con una certa forza con il calcio. Constatammo tutto questo in linea teorica perché non avemmo mai in dotazione le cartucce- Senza il corredo dei caricatori potevano essere paragonati purtroppo a manici di scopa.
Intanto, se nel frattempo riuscivo a conquistarmi l’animo del colonnello, il mio cuore ed il mio cervello erano tormentati dalle notizie che pervenivano, anche se frammentarie, dai vari fronti di guerra e non potevo nascondermi che aumentava con l’evidente disagio, anche il desiderio e la nostalgia della famiglia che non vedevo ormai da moltissimo tempo.
Che la guerra si avvicinasse sempre più minacciosa lo constatammo dalle più frequenti incursioni aeree. Incursioni che si facevano più minacciose e costringevano a pensare che ormai non c’era molto da aspettare. I quadrimotori volavano ormai molto bassi a mano a mano che le difese contraeree si facevano più deboli. Era uno spettacolo terrificante vederli così immensi con i pancioni carichi di morte che inesorabilmente venivano scaricati sul campo di aviazione di Comiso dopo essere passati bassissimi sulle nostre teste.
Ragusa non possedeva alcuna difesa né territoriale né contraerea: tutti i presìdi erano stati trasferiti e sul territorio eravamo rimasti noi, del nucleo antiparacadutisti, ed il presidio del distretto militare, fra l’altro ridotto ai minimi termini con personale non idoneo per reparti combattenti.
Chiesi al comandante di poter godere della licenza e mi fu promessa dopo che avessi provveduto alla costruzione di alcune trincee di difesa nei punti strategici della città. L’ordine era giunto dai comandi superiori come un rimedio sicuro contro un nemico, che, una volta messo piede in Sicilia, si fosse presentato, sic et simpliciter, alle porte di Ragusa.
L’ordine mi fu passato come se io fossi stato un ingegnere del genio esperto di difese passive. Tuttavia mi misi in moto, feci le mie brave ricognizioni e quindi con alcuni grafici che riportai con un lucido sulla carta topografica espressi la mia opinione pratica disegnandole sulle grandi strade di entrata della città e la presentai, per il suo esame e la sua opinione, al colonnello.
Per la verità quando le vide non solo le approvò, ma ne rimase addirittura entusiasta, soprattutto per il modo con cui le avevo non solo concertate ma anche per come le avevo espresse sulla carta: per la verità ne sapeva certamente meno di me.
Mi misi subito all’opera con i miei soldati e dopo un lavoro massacrante perché lavoravamo sulla roccia affiorante potemmo consegnare, diciamo, il lavoro ultimato. La mia licenza fu ulteriormente rimandata perché giunse l’ordine di costruire un riparo per il camion onde evitare che, rimanendo all’aperto, potesse essere oggetto di avvistamento da parte della ricognizione aerea nemica. Da ingegnere della difesa passiva divenni un ingegnere edile e potei presentare un progetto per la costruzione in muratura del riparo.
Gli Anglo-americani intanto avevano occupato la Tunisia e le nostre truppe si erano arrese con l’onore delle armi. Ormai erano alle porte e certamente il braccio di mare che li separava dalla Sicilia non era troppo vasto per pensare che fosse impossibile valicarlo.
L’aeroporto di Comiso doveva essere diventato un immenso colabrodo per le numerosissime volte in cui era stato oggetto di terrificanti bombardamenti aerei.
Pantelleria, intanto, si arrendeva agli Anglo-americani dopo circa una settimana di intensi bombardamenti aerei e navali. Ormai le truppe mancavano di acqua e di viveri, almeno questo fu il comunicato di guerra, e l’ordine di resa fu dato direttamente dal capo del governo. Lo spazio tra noi e il nemico si restringeva ulteriormente.
In una mattinata in cui eravamo intenti a completare il garage venne all’improvviso un’ispezione da parte del comando di corpo d’armata con a capo addirittura un generale accompagnato dal colonnello comandante la sottozona e vari altri ufficiali specializzati in amministrazione e via di seguito. L’ispezione fu attenta e minuziosa alla camerata, all’armeria, alla cucina, al lavoro che stavamo facendo ed io stesso fui sottoposto ad innumerevoli domande sull’addestramento, sull’impiego delle armi, sul morale dei soldati, sull’impiego in caso di necessità, sulla bontà dei mezzi che avevamo in dotazione. Fu un esame universitario su tutti i fronti, anche quello tattico.
Quando finalmente fui libero perché l’ispezione era finita vidi che il generale era alquanto perplesso. In un secondo tempo seppi i motivi di questa perplessità dalla bocca dello stesso colonnello che mostrò di essere felice come una Pasqua. In altri termini il generale non era del tutto convinto che la situazione del Nucleo fosse continua e non occasionale e dovette intervenire lo stesso colonnello per assicurargli che lo stato del nucleo era quotidiano ed esemplare così come il generale in persona aveva potuto constatare.
Per questa visita ebbi un posticino d’onore con una citazione sull’ordine del giorno del Comando di corpo d’armata. Venni a conoscere la notizia dal comando di sottozona ma non ebbi mai modo di leggerla di persona. Fui felice ugualmente perché avevo sommato a mio favore un altro punticino di merito.
Come conseguenza immediata ci fu che il capitano addetto alla sorveglianza ed al coordinamento dei nuclei e che era di stanza a Ragusa fu spedito altrove perché nella sede non c’era bisogno della sua presenza. Così mi toglievo dalla scarpa una altra pietruccia su cui ero stato costretto a camminare da quando avevo mostrato con chiarezza e senza infingimenti quanto il capitano stesso mi stesse sullo stomaco. Mi venne persino a salutare non senza un po’ di rammarico, forse pensando che fossi stato io stesso l’artefice di quel provvedimento. Non lo avrei fatto in nessun caso perché mio padre mi aveva insegnato che non dovevano parlare le persone ma i fatti ed i fatti avevano parlato a mio favore.
Avemmo un giorno di grande fatica quando fu segnalata la caduta di paracadutisti. Non c’era stato nessun lancio ma potemmo vedere direttamente uno spettacolo impressionante di un quadrimotore di ritorno verso Malta che a velocità ridotta cercava di guadagnare il mare.
Un caccia, che sembrava un moscerino rispetto alle proporzioni dell’immenso aereo, lo stava prendendo a bersaglio girandogli intorno più e più volte con delle micidiali mitragliate indiavolate. Ho sentito grande ammirazione per quel pilota.
Non sapevo se era un tedesco o un italiano ma in quel momento ed in quelle condizioni meritava il massimo del rispetto.
Ad uno ad uno poi vennero fuori dall’aereo i membri dell’equipaggio per salvarsi con il paracadute. Il caccia non infierì sui paracadutisti ma continuò a mitragliare l’aereo che non voleva cadere in alcun modo. Vedemmo poi in lontananza forse ormai all’altezza del mare il velivolo perdere quota e poi non lo vedemmo più. Non andammo a recuperare i paracadutisti perché ormai erano lontani dalla nostra giurisdizione e toccava ad altri adempiere a quel compito di recupero.
Tornammo nella nostra caserma quando già era sera tarda ed eravamo stanchissimi per aver percorso una strada assolutamente impraticabile e con salite e discese da far dispetto persino ad un alpinista. Le mie “cipolle” agli alluci destro e sinistro erano cotte, proprio, è il caso di dirlo, stracotte.
Quella stessa sera il colonnello comandante mi comunicò per telefono che il giorno successivo mi avrebbe firmato la licenza: non me la dava quella stessa sera perché doveva provvedere prima alla mia sostituzione.
Il giorno dopo non ebbi la licenza ma la comunicazione che eravamo in allarme rosso. Non era preallarme come qualche altra volta era accaduto, ma allarme vero e proprio. I miei Penati si stavano scordando di me.
Come seppi in un secondo tempo, la flotta americana e quella inglese si erano mosse in massa dai porti algerini e tunisini e non c’era più un’altra Pantelleria da conquistare.
Dove sarebbero andati a finire? Che cosa sarebbe accaduto? Quali piani di sbarco avrebbero adottato?
La mia mente e la mia logica mi facevano sapere che quasi con millimetrica precisione sarebbero sbarcati proprio sulle spiagge di Marina di Ragusa che era situata dinanzi ai nostri occhi. Perché? Perché, e loro lo sapevano meglio di noi, in questa zona non avrebbero trovato una resistenza degna di questo nome oltre una prima ed una seconda fila di fucilieri armati di fucile modello ’91 in trincee scavate nella sabbia e con un retroterra assolutamente sprovvisto di difese attive o passive che fossero. Non ci voleva una mente preparata alla più grande strategia per capire una elementare condizione di facilità per uno sbarco, anche non in grande stile.
Seguirono giorni di calma apparente intervallati da scoppi, che sembravano non coordinati ma che servivano certamente a tenere gli animi in tensione continua Comunque nel reparto parlavamo poco e non saprei dire il perché, forse ognuno maturava un certo progetto ed aveva timore di chiarirlo agli altri. Certo è che i soldati avevano molto più contatto con la popolazione e potevano, meglio di quanto potessi fare io, conoscerne l’umore, le attese, i timori o forse anche le speranze.
Sicuramente non aveva sortito un effetto favorevole un proclama, che si leggeva su tutti i muri, del generale Roatta, il quale, rivolgendosi ai Siciliani suonava in un certo modo come se la Sicilia fosse un protettorato o un lembo di terra che non faceva parte della madre patria italiana. Infatti cominciava così: «Siciliani, aiutate i camerati Italiani e tedeschi etc etc…”.» Non vado oltre perché ancora oggi mi sento ferito fino in fondo a tutto il mio essere Italiano per educazione, per convinzione profonda, per inalterato sentimento.
L’animo era sempre più triste e non c’era voglia di ridere e di scherzare, quando invece eravamo abituati a conversare felicemente fra di noi senza eccessive differenze di grado e di cultura. Sentivo l’affetto dei miei uomini e li ricambiavo di tutto cuore ma sentivo anche che c’era anche molta prudenza nelle loro parole. Forse direi meglio reticenza per qualcosa che sapevano e che non azzardavano pronunciare. Era forse presentimento? Si, penso di si.
Tutto faceva pensare che eravamo giunti all’epilogo, un epilogo disastroso per tutti, che annullava il domani più che per l’incertezza, per una certezza questa volta assolutamente negativa: ce la sentivamo sullo stomaco, nei sogni, e soprattutto nei pensieri.
Il colonnello mi mandò a chiamare: mi comunicò che l’allarme era finito e mi consegnò la licenza firmata, dovevo soltanto aspettare il giorno dopo, fin quando fosse arrivato il tenente che doveva sostituirmi. Mi si allargò l’animo come se mi sentissi in paradiso, in una splendida luce di gioia. Così, dopo averlo ringraziato, ebbi finalmente la forza di sorridere contenendo invece la voglia di esplodere in un urlo di liberazione.
Tornato all’accantonamento firmai la licenza a due miei soldati che come me avevano atteso il loro turno di partenza. Dopo pochi momenti erano già spariti per prendere il primo treno possibile. Ero completamente rilassato, con i nervi finalmente distesi e con una felicità che non riuscivo più a nascondere: il giorno dopo sarei partito, sarei partito, capite? Partito per andare a casa, per vedere la mia famiglia anche se in formato ridotto perchè uno dei miei fratelli, il maggiore, comandava una batteria di artiglieria campale in quel di Castelvetrano ed il minore, ma sempre più grande di me, sottufficiale dei Carabinieri sperduto nei contrafforti dell’Albania. Mio padre, sottufficiale dell’esercito, era ancora in forza presso il Comando Deposito del 3° Reggimento fanteria di stanza a Messina.
Solo mia madre non era sotto le armi ma in compenso viveva le vicissitudini di ciascuno di noi con gli occhi al cielo e con la preghiera sulle labbra. Povera mamma! L’avrei rivista e riabbracciata da li a poco, il tempo che la “vaporiera” mi portasse come una lumaca fino alla fermata della mia stazione di Messina. Quella scelta di tempo mi avrebbe portato distante dalla febbricitante ansia che, a mano a mano, stava per prendermi l’animo ed il cuore. Mi preparai la valigia e cominciai ad attendere, felice, finalmente felice.
.Tragico epilogo
Erano circa le ventidue quando senti squillare il telefono. In genere non sono ottimista quando sento trillare il telefono in orari isoliti ma questa volta il mio stato d’animo era euforico e non mi passò minimamente per la testa che potesse trattarsi di qualcosa di non gradito. Forse il mio futuro sostituto mi comunicava l’ora in cui presumibilmente sarebbe arrivato.
Presa la cornetta riconobbi la voce del colonnello: «Grillo, è stato segnalato un lancio di paracadutisti fra Marina di Ragusa e Ragusa. Con il reparto vai a presidiare la strada onde evitare che si verifichino infiltrazioni verso Ragusa stessa.»
Il mondo intero mi crollò addosso. Come poteva essere accaduto se l’allarme era appena cessato? Era un episodio isolato oppure faceva parte di un disegno più grande? Propendevo più per la prima ipotesi, visto che non c’erano stati segni di maggiore importanza e di più largo impiego – almeno così mi faceva pensare la segnalazione scarna e senza commenti – o contorni di altro genere.
In un attimo vidi tutto ed il contrario di tutto: ogni ipotesi contraddiceva quella che avevo formulato nella mia mente un secondo prima. Non avevo più tempo per pensare, dovevo agire e senza perdere un secondo in più di tempo.
«Si parte, ragazzi, forza, su, animo e via!», furono le mie prime parole, ma loro forse avevano intuito più di quanto non avessi capito io stesso. La massima parte di loro erano veterani e comprendevano che non c’era più da scherzare.
Eravamo molto bene organizzati ed in pochissimi minuti eravamo già sul camion in partenza. Non sapevo dove ci saremmo fermati perché solo il terreno avrebbe potuto suggerirmi la migliore soluzione per adempiere all’incarico. La luna ci aiutò a trovare quello che a me sembrò più adatto ed opportuno: un piccolo avvallamento che ci consentiva di guardare verso il mare e nello stesso tempo di non essere sorpresi alle spalle. Per questo motivo, appunto, collocai degli uomini che potessero dare l’allarme nel caso qualcuno venisse da quel lato: certamente con i paracadutisti era la cosa più facile che potesse accaderci.
A rifletterci la frase “Evitare che ci siano infiltrazioni” non faceva intendere che in atto ci fossero avvenimenti in grande stile per cui mi sentii quasi tranquillizzato per quello che era possibile in quel momento. Mi venne istintivo mettermi le mani in tasca e toccare la licenza bella e firmata, non volevo perderla: mi illudevo ancora che potessi usarla.
Comunque, non era quello il momento per pensarci: mi dedicai perciò all’opportunità di sentire ad uno ad uno i miei soldati e così quasi strisciando passai da uno all’altro per sentire le loro idee per conoscere non solo la loro opinione ma soprattutto il loro stato d’animo. Avevo quasi intuito dal loro improvviso silenzio che anche loro come me avevano le stesse precise perplessità e la volontà di non pensare a quello che eventualmente sarebbe accaduto di lì a poco.
Lo facevo soprattutto per dare loro coraggio con il mio personale intervento, per far capire che ero lì insieme a loro, che la mia vita era con la loro vita. E se era vero che non mancava il pericolo, che anzi era imminente ed immanente, in ogni caso io avrei condiviso la loro sorte. Forse c’era una seconda verità un pochino più recondita ma non per questo meno vera e cioè che ero io ad aver bisogno di loro, di sentirmeli vicini, per far tesoro della loro esperienza, soprattutto.
Ero in uno stato che non riuscivo a determinare con esattezza ma che per sensazioni e per sentimenti si avvicinava, come dire, alla levitazione. Ero pieno di vuoto, agivo per delega, in funzione di quello che avevo imparato a fare nei casi che, virtualmente, erano stati predefiniti da continue esercitazioni e che per questo le mie decisioni non erano prese perché reagivo ai fatti concreti che si svolgevano intorno a me, ma li vedevo come se fossero lontani dalla realtà presente e li vedevo come se fosse un altro a vederli. Non avevo paura ma non avevo neppure coraggio.
Forse sarebbe stato meglio che qualche altro vicino a me mi desse gli ordini da eseguire, in quel caso sarei stato capace persino di contestarli se li avessi considerati non idonei, ma allora, in quel preciso momento, la domanda che mi assillava era se stavo facendo bene o se stavo operando in modo da mettere inutilmente in pericolo la vita dei miei soldati e, perché no, anche la mia.
La luce della luna era intanto a poco a poco declinata e non sentivamo muovere una foglia intorno a noi malgrado la tensione avesse raggiunto dimensioni straordinarie. Ormai non parlavamo più per non dare segni della nostra presenza e questo per ovvi motivi: non volevamo diventare preda per nessuno sperando che la sorpresa di trovarci lì da parte di altri fosse un motivo in più di difesa per noi. Non ebbi bisogno di dare ordini in tal senso perché ciascuno di noi lo sentiva come essenziale per la sopravvivenza e nessuno tentò di accendersi una sigaretta, anche se, come immagino, molti di noi ne sentissimo la assoluta necessità. Il minimo errore ci sarebbe costato carissimo e noi quell’errore non lo commettemmo.
Poi all’altezza del mare vedemmo un faro che spingeva il suo fascio di luce lontano sventagliando i suoi raggi in un grande semicerchio. Per contro notammo in un bagliore repentino, una traccia luminosa che si sgranava in molteplici fasci di luce in prossimità della fotoelettrica.. Sopra di noi il rombo degli aerei si fece sentire e sul mare cominciarono ad innalzarsi verso il cielo molti colpi di contraerea: sulla sua superficie c’era qualcosa che non potevamo assolutamente vedere ed i nostri aerei cominciavano a bombardare.
Questa fu la mia prima considerazione visto che sul mare si verificavano degli scoppi evidentissimi e che sulle nostre teste gli aeroplani rombavano veloci con le luci accese, quindi non potevano essere che nostri.
Il mio caporal maggiore, quello, per intenderci, della medaglia di bronzo, mi si avvicinò strisciando e parlando a bassissima voce mi fece capire che quegli aerei non erano nostri e che andavano con le luci accese perché i loro portelloni erano aperti per permettere il lancio di paracadutisti.
Mi si agghiacciò il cuore: non c’erano più ipotesi da fare ma occorreva prendere atto di una situazione che da un momento all’altro sarebbe divenuta pericolosa. Da quel momento non ci furono più attenuanti che potessero farci sperare in una situazione diversa da quella che nella realtà era, e cioè gravissima.
Ad un certo momento, direi quasi all’improvviso, si scatenò la fine del mondo. Oggi con la visione di film che riproducono la stessa situazione si potrebbe dire che non c’è grande differenza da quello che vedemmo in quella notte da tregenda. Nelle pellicole cinematografiche dello sbarco in Normandia la vicenda fu riprodotta alle prime luci dell’alba perché soltanto da quel momento si iniziarono gli sbarchi ed i bombardamenti che li precedettero. Sulla costa che poteva intravedersi dalla posizione nella quale avevo disposto il mio reparto lo spettacolo fu di ben diverso genere, perché si svolse durante le ore notturne e quello che potemmo scorgere non potrei paragonarlo neppure ad uno spettacolo pirotecnico, non solo perché era di proporzioni molto più vaste: abbracciava l’orizzonte da oltre Pozzallo e si allargava al di là della costa di Gela. Soprattutto per la distruzione che si poteva indovinare sugli obbiettivi su cui si scaricava tutta quella massa di bombe e di proiettili esplosivi, proiettili che si aprivano a ventaglio sulle difese della spiaggia in una miriade di traccianti che si incrociavano come tante, tantissime comete maledette. Era assolutamente terrificante quello che stava riversandosi sulle povere difese della spiaggia, pensavo e pensavamo che sarebbe stato impossibile sopravvivere a tanto disastro di fuoco e di morte.
Cominciammo a vedere che Marina di Ragusa si incendiava, un enorme rogo di fiamme altissime. Tramite il motociclista inviai le notizie al Comando di sottozona e di lì a poco mi fu confermato che avrei dovuto impedire ad ogni costo infiltrazioni di qualsiasi genere: se non fosse stato un momento così straordinariamente drammatico, quel “ad ogni costo” mi avrebbe fatto sorridere. Forse ho anche sorriso, ma con una smorfia di profonda amarezza.
La tregenda di fuoco si protrasse per lunghissime ore e quando finalmente spuntarono le prime luci dell’alba, potemmo osservare uno scenario da apocalisse. La foschia, che tuttavia faceva sembrare lo spettacolo come una scena da sogno, non ci impedì di avere la precisa sensazione che ormai era finita: le navi alla fonda ed altre da guerra in continuo movimento erano innumerevoli e non avrebbero potuto essere enumerate in nessun caso, specie in quel momento di dolorosa certezza della catastrofe.Inviai un altro messaggio e questa volta mi si ordinò di tornare all’accantonamento.
Un’altra telefonata mi comunicò che era stata segnalata la presenza di paracadutisti alla stazione ferroviaria di Genisi e che avrei dovuto verificarne la veridicità. Chiesi il permesso di rifocillarci, permesso che ottenni con la raccomandazione di fare presto.
Mentre il reparto potette rifocillarsi alla bell’e meglio io non riuscii a mettere un boccone in bocca: avevo altro a cui pensare. Sulla carta topografica di cui ero stato fornito potei verificare la posizione della stazione e come la si potesse raggiungere seguendo un itinerario appena più lungo ma che ci avrebbe consentito di non andare a finire direttamente in bocca al lupo. Dopo pochissimi momenti partimmo per un destino che non avremmo potuto in ogni caso indovinare.
Raccomandai ai miei la massima prudenza: non eravamo più lì per una esercitazione. Non c’era dubbio ormai che ci trovassimo di fronte ad una realtà quanto mai incerta ma certamente, per usare un piccolo bisticcio di parole, dinanzi ad una realtà dolorosissima. Ed alla quale non ci si poteva sottrarre in alcun modo.
Rifacemmo il percorso fatto durante la notte precedente non senza una certa preoccupazione, perché non sapevamo che cosa potesse essere accaduto dopo aver lasciata la zona nella mattinata. Eravamo con i nervi tesi pensando che da un momento all’altro avremmo potuto trovarci dinanzi ad un fatto nuovo, non previsto, ma che in ogni modo poteva improvvisamente impegnarci.
Ad un certo momento imbroccammo una stradina in terra battuta sulla nostra destra e ci attestammo dopo qualche centinaio di metri in maniera in certo qual modo defilata perché, almeno da una parte, eravamo protetti da un grandissimo albero di carrubo. Con la massima attenzione ci disponemmo a semicerchio lungo la piccola valle che si apriva davanti a noi e guardando un rilievo che, secondo la carta topografica, copriva la stazione ferroviaria di Genisi.
In quel momento mi resi conto che se la stazione fosse occupata veramente dai paracadutisti ci saremmo esposti come probabile bersaglio. Ormai era troppo tardi per prendere decisioni diverse perciò mi parve opportuno neutralizzare, in parte, quella cattiva situazione allargando al massimo il ventaglio del nostro dispiegamento.
Cominciammo a muoverci e con noi volle unirsi l’autista, perché voleva a tutti i costi far fuori un americano. Questa vicenda, che mi piace ricordare, ci convinceva sempre di più che questa volta avremmo visto in faccia il nemico. E, invece, il nemico non lo vedemmo neppure in quella occasione.
Quando giungemmo alla stazione dopo aver superata una scarpata che, a dire scoscesa è poca cosa, eravamo esausti. Incontrammo il personale della stazione che ci disse che non avevano visto nessuno e che i treni già dalla mezzanotte non transitavano più.
Oggi non so dire se eravamo delusi o felici di non averli incontrati. Ormai eravamo convintissimi che ci saremmo scontrati e, per la verità, non fummo perfettamente convinti che non ci fosse stata detta una bugia. Per esserne sicuri perlustrammo in un largo raggio tutta la zona circostante ed in effetti non avemmo modo di vedere paracadutisti di nessun genere. In un certo senso mi lasciò perplesso una certa ansia che era scritta a caratteri cubitali sul viso di ciascuno del personale e poi mi sembrò che avessero fretta di mandarci via dal posto con il volerci rassicurare incessantemente che lì non c’era proprio nessuno.
Invece, forse anche per quella impressione, ci mantenemmo sul posto abbastanza a lungo fino a che non fummo sicuri che almeno da quella parte i paracadutisti non c’erano.
Tornammo sui nostri passi fino al camion ma con molta circospezione: c’era infatti la probabilità che vedendoci si fossero sottratti alla nostra vista e che poi avessero tentato di tagliarci la strada.
Ho avuto occasione di precisare che la mia mente era come svuotata dinanzi agli avvenimenti che stavano precipitando dinanzi a noi, sempre pensando se agissi sotto l’azione della paura o se mi muovessi invece spavaldamente sotto l’influenza di un incosciente furore di coraggio. Ero dunque lucidissimo e come potevo ben capire anche i miei soldati erano altrettanto lucidi. Erano silenziosi ma nessuno dette segni di scollamento o di indecisione: infatti avevano seguito tutte le mie indicazioni senza mostrare tentennamenti ed ebbi la precisa sensazione che si fidassero molto delle mie decisioni, forse perché si erano accorti che ogni mio ordine era improntato alla necessità di fare tutto quello che era dovuto ma con opportuna cautela, quella cautela che ci consentiva di non andare allo sbaraglio. Avrebbe potuto accaderci di tutto anche a quelle condizioni ma, almeno in quel caso , non sarebbe accaduto per eccesso di sicurezza o di inopportuna caparbietà.
Rientrammo facendoci precedere dalla necessaria comunicazione di tutto quello che era stato fatto e di quello che avevamo visto. Lo stesso motociclista ci portò l’ordine di ripartire immediatamente per impedire che truppe nemiche avvistate lungo la strada Ragusa-Comiso potessero avvicinassi alla città.
Pensai per un attimo alle difese che avevo fatto costruire dai miei soldati proprio con lo scopo di opporci all’eventuale avvicinamento a Ragusa di truppe nemiche, ma .invece ci spingemmo molto più oltre. Avevamo avuto per altro l’indicazione che il nemico si era attestato in prossimità di un quadrivio quasi a mezza strada fra Comiso e Ragusa.
Ogni tanto ci fermavamo e mandavamo avanti in perlustrazione alcuni uomini che potessero garantirci la sicurezza per un altro passo avanti. Sentivamo in lontananza il rombo tumultuoso delle cannonate che ormai distinguevamo da quelle dei bombardamenti aerei. Ed a tratti sembravano allontanarsi per riavvicinarsi poi con un crescendo di tuono sempre più possente e sempre più pericoloso. Non avevamo però la possibilità di capire se l’una o l’altra alternativa fosse da considerarsi quella più negativa per noi. Comunque era ormai certo che da qualche parte, e certamente non molto lontano, si combatteva con accanimento e con alterna fortuna. Stabilirlo in quel momento non era affatto possibile perché anche noi avevamo una gatta da pelare non meno pericolosa.
Deviammo dalla strada principale per raggiungere una fattoria dove trovammo dei contadini in allarme. Comprendemmo che la loro preoccupazione non era la presenza degli americani ma la nostra perché certamente i nostri soldati avrebbero attirato sulla fattoria il fuoco del nemico. Oggi non sono molto sicuro che gli americani fossero considerati nemici più di quanto non potessimo essere noi stessi, quelli che i contadini temevano di più. Consigliai a tutti loro di ritirarsi nelle loro case e di non farsi vedere più per nessun motivo. Una contadina, preso il coraggio a due mani, mi supplicò di allontanarci per non compromettere con la nostra presenza la salvezza dei bambini e di tutti loro.
Non ebbi neppure la facoltà di commuovermi e neppure ne ebbi il tempo, perché i miei soldati avevano avvistato gli americani attestati al di là di una piccola valletta sulla strada principale: erano la maggior parte seduti per terra, alcuni erano intenti a perquisire i carri dei contadini che andavano verso Ragusa con i loro carichi di paglia e di altro che noi a quella distanza non avevamo certo la possibilità di accertare.
Si muovevano spesso e forse i più stavano rifocillandosi ignorando del tutto la nostra presenza. Non pensavano che ci potessimo avvicinare a loro senza che ci avvistassero. Forse in questo la mia tattica era quasi perfettamente riuscita.
Disposi i soldati dietro i muretti a secco lentamente ma con una certa distanza fra ciascun elemento ed ordinai che non sparassero se non dopo che l’avessi fatto io stesso. Ma, come si dice, l’uomo propone e Dio dispone. Evidentemente qualcosa non deve aver funzionato perché la sorpresa venne meno: forse un elmetto forse un luccichio, forse un riflesso inopportuno destò un allarme prematuro e così potemmo notare un corri-corri affannoso come se avessimo messo il piede su un formicaio.
E non fummo più noi a sparare per primi: una pioggia di proiettili si rovesciò sul nostro reparto come una grandinata tempestosa. Al fuoco rispondemmo, anche se non con la stessa intensità. D’altra parte non avremmo potuto mai raggiungere quella stessa potenza di fuoco, visto che il nostro armamento era quello che era. Il nostro compito non era quello di sterminarli e neppure quello di impegnarli ma soltanto di riferire quale era la situazione, dove erano i paracadutisti e quanti erano. Conosciuta con una certa approssimazione quale era la realtà cominciammo a ritirarci.
Lo facemmo con buon tempismo e seguendo le norme che mi avevano insegnato alla scuola allievi ufficiali. Ci ritirammo un gruppo alla volta lasciando che il rimanente tenesse a bada i paracadutisti con il fuoco continuo. Raggiungemmo il camion che avevamo defilato dietro la fattoria e tornammo sulla strada principale. Facemmo appena in tempo a raggiungerla quando ci accorgemmo che un loro reparto stava per chiuderci la strada. Bastò una prolungata raffica di mitragliatrice per costringerli a bloccarsi. Tornammo a fermarci dopo qualche centinaio di metri con la copertura di una casa cantoniera disabitata e lì ci disponemmo lungo tutto il muretto a secco che ci offriva l’unico possibile riparo.
Emozioni? Non saprei dire: era come se agissi secondo un copione prestabilito con una certa approssimazione di cui io non ero l’autore e perciò non potevo permettermi correzioni o iniziative che non fossero previste dal copione stesso. Mi muovevo indipendentemente da quello che passava per il mio cervello per cui non potetti permettermi il lusso di avere paura.
Il porta-ordini partì per raccontare i fatti e noi rimanemmo in attesa, in attesa di che cosa non riuscirei mai a dirlo: aspettavamo, sì, aspettavamo.
Ad un certo momento vedemmo venire verso di noi due militari in non perfetta tenuta di ordinanza. Erano due soldati tedeschi che però non feci avvicinare più di tanto per evitare sorprese e dopo averli costretti a mettere a terra le armi. Seppi dal loro racconto alquanto concitato che gli americani erano a poca distanza e che loro erano riusciti ad aggirarli fino al momento del nostro incontro. Non avevo più motivo di dubitare della loro versione, pertanto feci riprendere le loro armi e così venni a sapere che appartenevano alla marina tedesca e che erano dislocati per il funzionamento della fotoelettrica che avevo notato in azione durante la notte. Non potei nascondere la mia ammirazione così come avevo pensato durante la notte quando avevo visto la sua luce sventagliarsi sul braccio di mare davanti a Scoglitti.
Lasciai che andassero oltre anche se per un attimo mi passò per la mente che forse avrei avuto il diritto di pretendere che si fermassero con noi per condividere il nostro stesso compito. Non so se intesero per un attimo quali fossero le mie intenzioni perché cercarono di spegnere i miei ardori facendomi comprendere che era assolutamente inutile fare quello che stavo facendo in considerazione dell’enorme numero di mezzi con cui gli americani erano sbarcati e dell’immenso volume di fuoco di cui disponevano.
Sorrisi e li salutai augurando loro una migliore fortuna. Naturalmente pensavo ad una fortuna migliore della mia perché ero convinto che quella in cui mi trovavo fosse una situazione senza via di uscita.
Spuntarono a distanza con un mezzo celere su cui era montata una mitragliatrice ma quando aprimmo il fuoco contemporaneamente con un sorprendente volume di fuoco sterzarono velocemente invertendo in tutta fretta la marcia.
Dopo pochi minuti un aereo venne sulle nostre teste con l’evidente compito di trovarci e di convincerci con le buone o con le cattive che lì, dove eravamo, non stavamo bene. Si allontanò forse senza vederci o se ci vide considerò la nostra consistenza e non volle sprecare proiettili. Nel frattempo giunse il motociclista con nuovi ordini. Dovevamo ritirarci in caserma e restarvi in attesa di ordini … che non giunsero mai più. Era proprio finita.
L’esistenza del 454° Nucleo Antiparacadutisti di stanza a Ragusa per la sua difesa ebbe termine. Il giorno successivo, infatti, con una convergenza straordinaria Ragusa fu investita dal sud e dal nord da truppe e mezzi americani da una parte e canadesi dall’altra. Gli americani si fermarono e lasciarono la precedenza ai canadesi, che dopo un colpo di cannone dimostrativo che colpì uno dei tanti campanili, occuparono la città.
Considerazioni conclusive sul primo volume
Sono passati appena sessanta anni [il preside Grillo scrisse le sue memorie nel 2004,ndr] da quando si sono verificati gli avvenimenti che ho descritti. I fatti sono tutti verissimi perché supportati da una memoria ancora, fortunatamente, aperta e perché no, vivace. Tutto quello che non ho raccontato è perché non ho potuto verificarlo se non attraverso un ricordo traballante ed incerto e pertanto non eccessivamente sicuro e corrispondente alla “vera” verità.
La questione principale è che soprattutto dopo le vicende raccontate la vita non mi riservò eccessive fortune per cui il travaglio, le difficili condizioni di vita, il disagio fisico e soprattutto intellettuale mi indussero spesso a tirarmi fuori dalla massa e a fare una vita tutta mia che non mi fu certo utile.
Spesso, nella mia solitudine virtuale, per salvarmi, almeno così credevo, da tutto il futile che vedevo in tutto ciò che mi circondava, mi creavo artificiosamente un realtà tutta mia che tuttavia non era la realtà. Spesso nei miei sogni rivedevo tutto ciò che avevo sofferto ma in forma assolutamente diversa, non rispondente ai fatti realmente avvenuti. Così accadeva che il sogno si sovrapponesse e mi lasciasse nel dubbio tutte le cose.
Ad un certo momento i sogni, o forse è meglio dire gli incubi di cui soffrivo, non mi facevano più distinguere quello che era vero da quello che era falso. Purtroppo la loro verosimiglianza era tale che la confusione avveniva in modo da eliminare in me stesso ogni possibilità di distinzione, causando sovente la distruzione sistematica del ricordo, manomesso, distorto e confuso.. Come direbbe oggi uno specialista rimuovevo dalla mia mente tutto ciò che non accettavo e ricordavo soltanto quello che mi faceva piacere.
Non sono d’accordo del tutto su questa facile sentenza, infatti mi capita di ricordare anche quello che non desideravo affatto ricordare e butto alle ortiche anche cose che forse sarebbero state ben riposte nella mia memoria. Facendo un riesame di tutti gli avvenimenti mi viene spesso difficile metterli in ordine cronologico e più spesso li ho collocati un poco alla rinfusa senza però menomarne la veridicità. Avrei potuto con un non difficile controllo storiografico riordinarli secondo una sequenza storica, ma alla fine non ho voluto farlo perché, forse, avrei compromesso la spontaneità del mio racconto.
Soprattutto, non tocca a me fare da storico e mettere le cose in buon ordine, una dopo l’altra, su di un bel mobile di antiquariato. Mi interessava e mi interessa molto di più mettere in evidenza quello che i fatti suscitavano nel mio animo ed in quello dei miei soldati. In effetti non tradivo le vicende e non sono mai arrivato ad un compromesso perché tutti i fatti raccontati sono veri e, direi, verificabili.
Non ho descritto soltanto ciò di cui non ero ed ancor oggi non sono sicuro a causa anche di vuoti di memoria che ho cercato di spiegare un momento fa con motivazioni di cui non sono poi tanto certo.
Molti collegamenti sono saltati via e non solo perché sono passati oltre sessanta anni. Non so infatti come sia accaduto ed in che modo poi io sia andato a finire nella prefettura con alcuni ufficiali del distretto militare.
Non ricordo affatto come sia stato portato e con che mezzo fino ad Ispica in un recinto sorvegliato da sentinelle canadesi. Ricordo invece come sia andato a finire nel porto di Siracusa con un viaggio sui trucks sempre delle truppe canadesi.
Ho perfettamente in mente la partenza da Siracusa, dopo un intermezzo drammatico per una marcia, andata e ritorno, Siracusa-Priolo-Siracusa. Sono ormai fatti che non intendo raccontare, in questo momento, perché non fanno parte degli episodi vissuti nel Nucleo Antiparacadutisti. Lo scrivo persino con le lettere maiuscole, perché è parte integrante della mia vita. Vi ho trascorso dai venti ai ventitré anni, forse i più difficili fra i miei, ad oggi, ottantatré. Certamente mi necessita dire che sono stati i più difficili e non i più drammatici perché, purtroppo, il dramma non venne meno nella mia vita successiva.
Sicuramente da allora diverse cose meriterebbero di essere menzionate, ma ne vale la pena? Sono forse importanti per me ma agli altri quale interesse può alimentare una vita non propria? In definitiva, quello che ho scritto è servito soltanto a me stesso e non ha la minima ambizione di farsi ascoltare da qualunque altra persona. In altri termini ho soddisfatto una mia esclusiva esigenza che riempie alcune ore del mio quotidiano e mi fa provare le stesse identiche emozioni che ho provato quando le ho vissute.
E questa, cari miei, è vita. Sto osservando un film. Bello? Non lo so ma è mio, soltanto mio. Voglio unire a questo mio racconto una considerazione: non ho di proposito fatto i nomi di nessuno, ma, per la verità, all’ottanta per cento, li ho impressi tutti nel mio cuore e se potessi ritrovarli lo farei con grandissimo piacere. Di alcuni ho avuto notizie indirettamente e, guarda un po’, sono contentissimo che al ricordo della mia persona abbiano espresso sentimenti di grande stima.
Mi riferisco, per non fare un giro di parole troppo lungo, all’ex comandante della nona sottozona di Ragusa che mio fratello ebbe modo di incontrare alla Legione dei Carabinieri di Napoli. Il comune cognome fra me e mio fratello fece scattare il momento della memoria.
Oggi, sono felice di questo epilogo perché riassume in pochissime parole di stima tutto il comportamento di una vita, la mia, la cui valutazione era dettata da una visione unilaterale senza riscontri oggettivi che provocassero in me, nel mio animo e nella mia memoria una certa soddisfazione, oltre alla certezza di non aver operato male, almeno nella mia vita militare.
Articolo correlato:
Volume secondo https://wp.me/p60RNT-75m